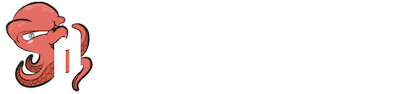Voto: 5/10 Titolo originale: The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning , uscita: 05-10-2006. Budget: $16,000,000. Regista: Jonathan Liebesman.
Recensione story: Non aprite quella porta – L’inizio di Jonathan Liebesman (2006)
06/09/2025 recensione film Non aprite quella porta - L'inizio di Marco Tedesco
Un'opera che cerca il confronto con l’originale di Hooper ma trova violenza ripetitiva, personaggi esili e un'icona svuotata

Erede diretto dell’ondata di rifacimenti e rilanci dei primi anni Duemila, Non aprite quella porta – L’inizio tenta di dare una genealogia a Leatherface ma finisce per raccontare più l’industria che il suo mostro. Il confronto con il capolavoro di Tobe Hooper del 1974 è impietoso proprio là dove dovrebbe contare: nel modo in cui la paura nasce e cresce.
L’originale costruiva la tensione con economia di mezzi, umorismo nero e suggerimento, lasciando allo spettatore il compito di riempire gli interstizi; il prologo del 2006 sostituisce quell’attesa con la reiterazione dello splatter, confondendo l’intensità con la quantità, la crudeltà con l’angoscia. Ne esce un percorso di sofferenza programmatico, privo di catarsi, che pretende di scandalizzare ma raramente inquieta davvero.
La narrazione funziona per un tratto: quattro giovani, due dei quali legati alla leva per il Vietnam, attraversano il Texas, hanno un incidente e incrociano lo “sceriffo” che li conduce al casolare. Poi il racconto si arresta, si frantuma in stanze, funi, ferri, ferite, punizioni. L’antefatto familiare – il cambio di cognome da Sawyer a Hewitt, la nascita abbandonata, il lavoro al mattatoio, il licenziamento – promette spiegazioni ma offre solo etichette. Leatherface resta un’esistenza “così com’è”: ci viene detto da dove viene, non perché diventa ciò che vediamo. Anche il contesto storico, con bozzetti di America ferita e ragazzi in fuga o pronti a partire, rimane cornice decorativa, senza vibrare davvero con ciò che accade nella casa.
 La messa in scena recupera con perizia la fotografia granulosa che richiama gli anni Settanta e, a tratti, la regia stringe il quadro quanto basta per far percepire assedio e fatalismo. Alcuni omaggi sono efficaci: un salto dalla finestra, un pasto forzato che riecheggia il convito dell’anziano nell’originale, il pudore nel non svelare il volto del carnefice fino in fondo. Ma l’insieme resta sovraccarico: la catena delle sevizie si allunga oltre il necessario, la violenza perde peso specifico per saturazione e diventa rumore, non significato. Quando tutto è portato allo scoperto, nulla brucia davvero.
La messa in scena recupera con perizia la fotografia granulosa che richiama gli anni Settanta e, a tratti, la regia stringe il quadro quanto basta per far percepire assedio e fatalismo. Alcuni omaggi sono efficaci: un salto dalla finestra, un pasto forzato che riecheggia il convito dell’anziano nell’originale, il pudore nel non svelare il volto del carnefice fino in fondo. Ma l’insieme resta sovraccarico: la catena delle sevizie si allunga oltre il necessario, la violenza perde peso specifico per saturazione e diventa rumore, non significato. Quando tutto è portato allo scoperto, nulla brucia davvero.
Il cuore drammatico si sposta sul personaggio dello “zio” Hoyt: R. Lee Ermey ha presenza e ritmo, ma l’interpretazione scivola spesso nel grottesco consapevole, fino a divorare lo spazio dell’icona che dovrebbe legittimare. Leatherface, paradossalmente, resta in secondo piano, più strumento che entità tragica, mentre i giovani sono figure usa-e-getta. Jordana Brewster e Diora Baird reggono il registro della “scream queen” con professionalità, ma i dialoghi sono poveri e non concedono spessore; gli altri comprimari esistono come bersagli. In assenza di caratteri riconoscibili o desideri contrastanti, la sofferenza non genera empatia, solo assuefazione.
La differenza più netta rispetto al film di Hooper è etica prima che estetica. Là il male aveva una forma sociale e quasi domestica, insinuata tra economia, famiglia e deserto morale; qui la ferocia è fine a sé stessa, accumulata come se bastasse a legittimare un marchio. L’idea di raccontare l’origine diventa un pretesto: non illumina l’ombra, la appiattisce. Dove il modello costruiva un incubo che sembrava sgorgare dal terreno e dalla storia, questo prologo somiglia a un catalogo di modalità di offesa, con un finale cinico che confonde coerenza con disperazione programmata. La porta resta spalancata a nuovi capitoli, ma più per dovere industriale che per urgenza narrativa.
Eppure non tutto è da buttare: quando la regia di Jonathan Liebesman frena e si concede il tempo dell’attesa, la casa recupera il suo respiro mortuario; quando l’inquadratura si avvicina e non strepita, riemerge un briciolo di quella paura che nasce dal non detto. Sono istanti, lampi, promesse mancate. Se l’obiettivo era spiegare il mito, bisognava tornare al nervo scoperto che alimentava l’orrore originario: il rapporto tra corpi e territorio, tra famiglia e potere, tra lavoro e violenza. Senza questa linfa, “L’inizio” è soprattutto la prova di quanto sia facile scambiare il sangue per sostanza e la sofferenza per racconto.
In conclusione, Non aprite quella porta – L’inizio è un’opera che divide. C’è chi vi riconosce un passo avanti rispetto al rifacimento precedente sul piano della resa visiva e chi vi legge solo un raddoppio di sadismo; entrambe le posizioni colgono qualcosa di vero. Il film mostra mestiere, ma non visione; replica l’estetica, ma smarrisce l’anima. Se Leatherface doveva diventare leggenda attraverso la sua nascita, qui resta un enigma spiegato a metà: e un enigma spiegato a metà smette di fare paura.
Il trailer di Non Aprite Quella Porta – L’inizio:
© Riproduzione riservata