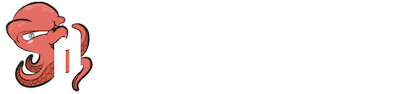Voto: 6.5/10 Titolo originale: Fantaghirò , uscita: 22-12-1991. Regista: Lamberto Bava. Stagioni: 5.
Dossier: Fantaghirò di Lamberto Bava, la fiaba come mito pop e rivoluzione televisiva
07/11/2025 recensione serie tv Fantaghirò di Gioia Majuna
Mito popolare, allegoria femminile e ultimo atto di un immaginario fiabesco italiano capace di trasformare la televisione in poesia visiva

Ci sono opere che, pur nate dentro i limiti della televisione generalista, riescono a oltrepassarli trasformandosi in mito. Fantaghirò, diretta da Lamberto Bava e trasmessa per la prima volta nel Natale del 1991, appartiene a questa categoria ristretta. Da una fiaba popolare raccolta da Italo Calvino, il figlio del grande Mario Bava costruisce un universo sospeso fra la memoria infantile e l’archetipo, una fiaba che parla di libertà, identità e desiderio travestita da intrattenimento familiare. La sua forza è quella delle immagini sincere: imperfette, a tratti ingenue, ma animate da una fede assoluta nella potenza dell’immaginazione.
Bava proviene dal laboratorio visivo dell’horror italiano e ne conserva l’impronta artigianale. Dopo Demoni e Macabro, il regista abbandona il sangue e la paura per dedicarsi alla luce e al sogno, ma non rinnega il suo passato: la tensione morale del gotico sopravvive nel fiabesco. Le scenografie dipinte, i controluce lattiginosi, i fondali nebbiosi e le armature che scintillano come reliquie mantengono un’impronta inquieta, come se dietro la magia si annidasse sempre la minaccia. È il passaggio dall’orrore alla meraviglia, ma con lo stesso stupore visivo; una metamorfosi che ricorda la trasmutazione alchemica fra ombra e oro che è al centro di ogni fiaba.
La principessa che dà il titolo alla saga, interpretata da Alessandra Martines, incarna la rottura di un modello. Fantaghirò non è la damigella da salvare, ma colei che salva, combatte e decide. Rifiuta il matrimonio combinato, si traveste da cavaliere e conquista il proprio destino con la spada e con l’intelligenza. È una figura liminale, sospesa fra identità maschile e femminile, un’eroina che si costruisce attraverso il travestimento e la performance. La sua ambiguità anticipa di decenni le discussioni contemporanee sull’identità fluida e sulla rappresentazione queer, ma lo fa con la grazia inconsapevole del mito. Come ha scritto Vladimir Propp, l’eroe fiabesco attraversa sempre un percorso di morte e rinascita; Fantaghirò lo compie nella forma del desiderio, convertendo la ribellione in conoscenza.
 Lamberto Bava rilegge Calvino con uno sguardo che appartiene alla modernità televisiva. La fiaba non è più il racconto di un mondo lontano ma una metafora del presente. L’ambientazione medievale, costruita fra Praga e Bratislava, è attraversata da un senso di decadenza che parla all’Italia di inizio anni Novanta, un Paese sull’orlo di mutazioni politiche e morali. Nelle sue torri e nei suoi castelli si riflette un desiderio collettivo di purezza e di fuga, ma anche la consapevolezza di un’innocenza perduta. È, in fondo, la stessa nostalgia che anima i mondi di Fellini e di Argento, dove il sogno diventa una forma di resistenza al reale.
Lamberto Bava rilegge Calvino con uno sguardo che appartiene alla modernità televisiva. La fiaba non è più il racconto di un mondo lontano ma una metafora del presente. L’ambientazione medievale, costruita fra Praga e Bratislava, è attraversata da un senso di decadenza che parla all’Italia di inizio anni Novanta, un Paese sull’orlo di mutazioni politiche e morali. Nelle sue torri e nei suoi castelli si riflette un desiderio collettivo di purezza e di fuga, ma anche la consapevolezza di un’innocenza perduta. È, in fondo, la stessa nostalgia che anima i mondi di Fellini e di Argento, dove il sogno diventa una forma di resistenza al reale.
La macchina di produzione che sostiene Fantaghirò è povera, ma funzionale. Senza effetti digitali, Bava si affida alla luce, ai filtri, ai trucchi ottici, alla forza del gesto teatrale. L’estetica è quella di un barocco tardo-televisivo, eppure mai gratuito: il fantastico nasce dalla povertà dei mezzi, come accadeva nel cinema di Méliès, dove il limite tecnico si trasformava in invenzione poetica. La fotografia e la musica di Amedeo Minghi, sentimentalmente magniloquente, concorrono a creare un’esperienza sensoriale che trascende il racconto. Non è un caso che molti spettatori ricordino Fantaghirò non tanto per la trama, ma per le atmosfere, per la sensazione di trovarsi in un sogno d’infanzia che non vuole finire.
La serie si muove sul confine fra pulp e fiaba, fra ironia e misticismo. In essa sopravvive il gusto gotico del Bava padre, ma anche una sorprendente dolcezza pop. Le streghe, le metamorfosi, i sortilegi sono presenze fisiche e simboliche insieme: come in ogni buona fiaba, il soprannaturale non è evasione, ma linguaggio del reale. Dietro la magia si nasconde una riflessione etica, quasi teologica, sul male, sull’identità e sul potere. Ogni antagonista – la Strega Nera di Brigitte Nielsen, la regina madre, i sovrani guerrafondai – rappresenta un frammento dell’ego da superare. L’eroina, per vincere, deve conoscersi.
Il rapporto fra Fantaghirò e Romualdo, interpretato da Kim Rossi Stuart, è la traduzione sentimentale di questa dialettica. Il loro amore attraversa incantesimi, trasformazioni, separazioni e riconciliazioni, ma non è mai puro romanticismo: è un rito di passaggio, una prova iniziatica. Nella loro unione si specchia il desiderio di conciliare opposti, maschile e femminile, razionalità e sentimento, potere e fragilità. L’amore diventa così conoscenza, e la fiaba si fa psicanalisi travestita da avventura.
Nel contesto televisivo italiano Fantaghirò è un caso irripetibile. Nessuna altra produzione dell’epoca seppe coniugare artigianato e ambizione in modo tanto coerente. Era la stagione dei kolossal natalizi di Mediaset, ma la serie di Bava spiccava per visione autoriale: una mitologia domestica creata per il piccolo schermo, in cui la meraviglia era alla portata di tutti. In un’Italia dominata da un immaginario mediatico aggressivo e maschile, Fantaghirò propose un altro modello di eroismo: non la conquista, ma l’empatia; non la forza, ma la gentilezza; non la guerra, ma il riconoscimento dell’altro. In questo senso, è anche una parabola politica, benché inconsapevole, sull’uguaglianza e sulla solidarietà.
Dal punto di vista visivo, la serie è un catalogo di simboli archetipici: lo specchio come soglia di identità, la spada come parola che recide l’ignoranza, il cavallo come energia vitale e sessuale. Ogni oggetto possiede un doppio significato, letterale e psicologico, secondo la logica di quello che Gilbert Durand chiamava “l’immaginario simbolico”. Il mondo di Bava è costruito come una mappa interiore, un paesaggio della mente più che dello spazio. Persino la fotografia lattiginosa, con i suoi filtri rosa e azzurri, sembra rimandare a uno stato di coscienza sospeso fra veglia e sogno.
La ricezione della serie conferma il suo carattere liminale. Trasmesse in oltre quaranta paesi, le cinque avventure di Fantaghirò sono diventate un oggetto di culto transnazionale. In Europa orientale, in Russia e in America Latina la principessa guerriera è stata adottata come figura mitica, una sorta di Giovanna d’Arco pop. In Italia, invece, è rimasta confinata nella nostalgia televisiva, citata con ironia ma raramente rivalutata con la serietà che merita. Eppure Fantaghirò è una delle poche opere italiane capaci di creare un universo mitopoietico coerente, riconoscibile e ancora vivo nella memoria collettiva.
 Oggi il personaggio è stato riscoperto dalle nuove generazioni attraverso i social network, dove la sua ambiguità di genere e la sua autonomia sono diventate simboli di un femminismo istintivo e non ideologico. Alcuni studiosi hanno visto in lei una delle prime eroine queer della televisione europea; altri la interpretano come la versione mediterranea di modelli internazionali come Xena o Buffy, ma più poetica e meno serializzata. È probabile che entrambe le letture siano vere: come ogni mito, Fantaghirò vive di ambivalenza.
Oggi il personaggio è stato riscoperto dalle nuove generazioni attraverso i social network, dove la sua ambiguità di genere e la sua autonomia sono diventate simboli di un femminismo istintivo e non ideologico. Alcuni studiosi hanno visto in lei una delle prime eroine queer della televisione europea; altri la interpretano come la versione mediterranea di modelli internazionali come Xena o Buffy, ma più poetica e meno serializzata. È probabile che entrambe le letture siano vere: come ogni mito, Fantaghirò vive di ambivalenza.
Riletta oggi, la saga di Bava sembra parlarci di un’epoca in cui la televisione era ancora capace di produrre sogni condivisi. Lontano dall’iperrealismo dei blockbuster contemporanei, Fantaghirò appartiene a una stagione in cui l’immaginario collettivo si costruiva attraverso la povertà e l’invenzione, non attraverso il digitale. La sua artigianalità è la sua forza: come il teatro barocco, tutto è finto, ma tutto è vero perché tutto è simbolico.
È difficile immaginare una produzione simile nell’industria odierna, dove la fiaba è stata colonizzata dal linguaggio del franchise. Ma proprio per questo Fantaghirò resiste, come un relitto luminoso di un’epoca in cui la fantasia era ancora un gesto politico. Guardarla oggi significa ricordare che la narrazione popolare può essere anche una forma di conoscenza, un modo per parlare di libertà, desiderio, identità, senza retorica e senza paura di essere ingenui.
Lamberto Bava, con mezzi minimi e visione massima, ha firmato un’opera che sfida la definizione di “serie televisiva”: un piccolo poema cavalleresco, un’ode alla possibilità che l’immaginazione sopravviva all’industria. Come in ogni vera fiaba, il lieto fine non coincide con la fine della storia, ma con la sua eternità. E così, trent’anni dopo, Fantaghirò continua a brillare nella memoria collettiva come una luce inesausta, la prova che anche nella televisione commerciale può nascondersi una forma d’arte capace di toccare il mistero.
© Riproduzione riservata