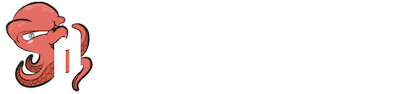Diario da Venezia 75 | Giorni 9 e 10: tra insulti sessisti, usignoli, ombre e rivoluzioni
08/09/2018 recensione film di Giovanni Mottola
Ultimi giorni di Mostra movimentati. Poi parliamo di The Nightingale, Shadow, Capri-Revolution e Process

La ragione per cui questa rubrica di cronache dalla Mostra del Cinema di Venezia è passata dalla cadenza quotidiana del primo periodo ad una a giorni alterni non risiede nella sopravvenuta pigrizia del suo autore, ma nel fatto che la seconda settimana è in genere molto più moscia: già proiettati i film più attesi, già passati i divi internazionali, si abbonda con restauri di vecchi capolavori, premi collaterali con corredi di discorsi di rito su quanto sia bello essere qui e via discorrendo. La stampa comincia a dileguarsi per altri lidi e chi rimane si scatena sui pronostici per le premiazioni. E’ dunque scoppiata quando ormai non ce la si attendeva più una polemica che ha riportato il Festival in prima pagina. Durante la proiezione stampa (cioè in anticipo rispetto a quella ufficiale con attori e regista in sala insieme al pubblico) di The Nightingale, unico film girato da una donna tra i circa venti del concorso principale, è infatti accaduto che allo scorrere del nome della regista Jennifer Kent sui titoli di coda, un giornalista o sedicente tale le abbia indirizzato le seguenti espressioni: “Vergognati, puttana: fai schifo!”.
 L’urlatore è stato individuato e risponde al nome di Sharif Meghdoud, che risulta essere un giovane cineasta torinese di nemmeno vent’anni, che nel 2016 ha diretto un film dal titolo La solitudine magnifica. Dopo aver urlato quegl’insulti, sulla sua pagina di Facebook ha pubblicato un lungo pezzo, alquanto sgangherato nei concetti, nel quale in sostanza si scusava per il fattaccio. Le reazioni non hanno comunque tardato ad arrivare: la Biennale ha deciso di ritirargli l’accredito seduta stante, impedendogli così di assistere a qualsiasi altra proiezione del Festival; Shiva produzioni, la testata per conto della quale scriveva in questa occasione, e che aveva provveduto ad accreditarlo, si è naturalmente dissociata – sempre attraverso Facebook – dal comportamento di Meghdoud e ha immediato cancellato ogni suo contributo presente online. La vicenda avrebbe potuto essere liquidata come il gesto volgare di una persona incapace non soltanto del minimo di educazione e misura per vivere in mezzo agli altri, ma pure di svolgere adeguatamente il mestiere di giornalista, ovvero di colui che ha tutto il diritto di stroncare un film (peraltro non piaciuto praticamente a nessuno), ma non certo andando sul personale, per di più in questo modo. Invece è diventata l’argomento del giorno, finendo col trascendere la cronaca ed essere utilizzata come spunto di riflessioni sui costumi del nostro Paese. I movimenti femministi non hanno perso occasione per farsi sentire, dimenticando che forse nel recente inasprimento delle contrapposizioni maschi/femmine potrebbero anch’essi avere qualche responsabilità. Ma l’ipotesi più inquietante e impossibile da escludere è quella che, nell’epoca dei social network, dove l’unica cosa importante sembra far parlar di sé, il signor Meghdoud abbia lucidamente architettato insulti preventivi e scuse successive solo allo scopo di fare un po’ di pubblicità alla sua carriera di piccolo cineasta. Di questo passo, quale diventerà il limite della decenza?
L’urlatore è stato individuato e risponde al nome di Sharif Meghdoud, che risulta essere un giovane cineasta torinese di nemmeno vent’anni, che nel 2016 ha diretto un film dal titolo La solitudine magnifica. Dopo aver urlato quegl’insulti, sulla sua pagina di Facebook ha pubblicato un lungo pezzo, alquanto sgangherato nei concetti, nel quale in sostanza si scusava per il fattaccio. Le reazioni non hanno comunque tardato ad arrivare: la Biennale ha deciso di ritirargli l’accredito seduta stante, impedendogli così di assistere a qualsiasi altra proiezione del Festival; Shiva produzioni, la testata per conto della quale scriveva in questa occasione, e che aveva provveduto ad accreditarlo, si è naturalmente dissociata – sempre attraverso Facebook – dal comportamento di Meghdoud e ha immediato cancellato ogni suo contributo presente online. La vicenda avrebbe potuto essere liquidata come il gesto volgare di una persona incapace non soltanto del minimo di educazione e misura per vivere in mezzo agli altri, ma pure di svolgere adeguatamente il mestiere di giornalista, ovvero di colui che ha tutto il diritto di stroncare un film (peraltro non piaciuto praticamente a nessuno), ma non certo andando sul personale, per di più in questo modo. Invece è diventata l’argomento del giorno, finendo col trascendere la cronaca ed essere utilizzata come spunto di riflessioni sui costumi del nostro Paese. I movimenti femministi non hanno perso occasione per farsi sentire, dimenticando che forse nel recente inasprimento delle contrapposizioni maschi/femmine potrebbero anch’essi avere qualche responsabilità. Ma l’ipotesi più inquietante e impossibile da escludere è quella che, nell’epoca dei social network, dove l’unica cosa importante sembra far parlar di sé, il signor Meghdoud abbia lucidamente architettato insulti preventivi e scuse successive solo allo scopo di fare un po’ di pubblicità alla sua carriera di piccolo cineasta. Di questo passo, quale diventerà il limite della decenza?
 Queste riflessioni sgorgano ancora più spontanee rivedendo la copia restaurata de Il posto di Ermanno Olmi, che è un film del 1961 ma racconta un mondo che sembra lontano anni luce da quello che ha partorito un personaggio come Meghdoud. Un film incentrato sulla ricerca del primo impiego da parte di un ragazzo che vive in una famiglia di gente povera e onesta della periferia di Milano. I rapporti tra genitori e figli, così come quelli tra coetanei di diverso sesso, sono all’insegna di un rispetto e di una delicatezza che, visti con gli occhi di oggi, risultano persino eccessivi, ma sicuramente preferibili a certi eccessi opposti. La grandezza di Olmi, come dimostrano Il posto e le altre sue opere, sta nell’aver spesso descritto un mondo che già nel momento in cui lui lo raccontava si stava estinguendo, consegnando così a futura memoria lo specchio di un’Italia diversa che sarebbe diventato oggetto di studio e in qualche caso anche di rimpianto. Curiosamente Mario Martone, il cui nuovo film Capri-Revolution è stato proiettato per il concorso principale quasi in contemporanea rispetto a Il posto, sembra condurci alle opposte conclusioni. Nella sua opera, ambientata nella Capri degli anni appena precedenti il primo conflitto mondiale, si racconta il conflitto tra una tradizione un po’ ottusa e un mondo che cambia, attraverso la storia della giovane Lucia (interpretata da Marianna Fontana, una delle due gemelle di Indivisibili di Edoardo De Angelis), attratta dal leader di una comune di giovani artisti dell’Europa del nord, liberi dalle rigidità tipiche dell’Italia di quegli anni. Martone compie un buon lavoro dal punto di vista storico – l’aspetto che più gli è congeniale, come dimostrò con Il giovane favoloso e con Noi credevamo – e dell’originalità nel descrivere i vagiti del cambiamento della società. A penalizzare in parte il suo film sono l’eccessiva freddezza dei toni e le interpretazioni non proprio memorabili degli attori.
Queste riflessioni sgorgano ancora più spontanee rivedendo la copia restaurata de Il posto di Ermanno Olmi, che è un film del 1961 ma racconta un mondo che sembra lontano anni luce da quello che ha partorito un personaggio come Meghdoud. Un film incentrato sulla ricerca del primo impiego da parte di un ragazzo che vive in una famiglia di gente povera e onesta della periferia di Milano. I rapporti tra genitori e figli, così come quelli tra coetanei di diverso sesso, sono all’insegna di un rispetto e di una delicatezza che, visti con gli occhi di oggi, risultano persino eccessivi, ma sicuramente preferibili a certi eccessi opposti. La grandezza di Olmi, come dimostrano Il posto e le altre sue opere, sta nell’aver spesso descritto un mondo che già nel momento in cui lui lo raccontava si stava estinguendo, consegnando così a futura memoria lo specchio di un’Italia diversa che sarebbe diventato oggetto di studio e in qualche caso anche di rimpianto. Curiosamente Mario Martone, il cui nuovo film Capri-Revolution è stato proiettato per il concorso principale quasi in contemporanea rispetto a Il posto, sembra condurci alle opposte conclusioni. Nella sua opera, ambientata nella Capri degli anni appena precedenti il primo conflitto mondiale, si racconta il conflitto tra una tradizione un po’ ottusa e un mondo che cambia, attraverso la storia della giovane Lucia (interpretata da Marianna Fontana, una delle due gemelle di Indivisibili di Edoardo De Angelis), attratta dal leader di una comune di giovani artisti dell’Europa del nord, liberi dalle rigidità tipiche dell’Italia di quegli anni. Martone compie un buon lavoro dal punto di vista storico – l’aspetto che più gli è congeniale, come dimostrò con Il giovane favoloso e con Noi credevamo – e dell’originalità nel descrivere i vagiti del cambiamento della società. A penalizzare in parte il suo film sono l’eccessiva freddezza dei toni e le interpretazioni non proprio memorabili degli attori.
 La Mostra ha poi offerto un altro film molto legato alla storia: l’ultimo lavoro del maestro cinese Zhang Yimou, Shadow (Ombra). La storia è ambientata in Cina nell’epoca dei Tre Regni (intorno al 220 d.c.) e prende le mosse dall’abitudine di re e nobili di farsi sostituire da sosia (le “ombre”) nei momenti di pericolo. Nel nostro caso, a farsi sostituire è il comandante di una città, chiamato dal sovrano della stessa a battersi contro il suo omologo di quella rivale, allo scopo di conquistarlo. Prima, durante e dopo la battaglia, la corte è funestata da intrighi di palazzo e vendette incrociate. Nulla da dire sulla fattura del film da un punto di vista tecnico, impreziosita dalla scelta del tono in grigio, che dà l’impressione del bianco e nero ed è perfetta per trasmettere allo spettatore un’atmosfera di dubbio, sfiducia e inganno. Ma è proprio questo clima di doppi giochi a non convincere: senza nessuna pretesa di spiegare la storia della Cina a un cinese, non ci si aspetta di vedere così poco senso dell’onore nel mondo orientale antico. L’unico personaggio al quale Zhang Yimou attribuisce la dignità di combattente valoroso è il generale della città da conquistare. Gli altri sono tutti infidi, privi di quel senso dell’onore che gli orientali antichi (cinesi o giapponesi che fossero) difendevano a costo di sacrificare la loro stessa vita. Tanto per capirci: un artificio come il Cavallo di Troia, simbolo dell’astuzia occidentale, un cinese non l’avrebbe mai adottato. Zhang Yimou racconta dunque una storia in cui di cinese, a parte i volti dei protagonisti e l’epoca storica, sembra esserci poco, come conferma anche una seconda parte tutta azione, in molti momenti inverosimile, che repentinamente prende il posto dell’introspezione della prima. Sintetizzandolo in una riga, potrebbe essere definito un film interessante per molti aspetti, ma non convincente per molti altri.
La Mostra ha poi offerto un altro film molto legato alla storia: l’ultimo lavoro del maestro cinese Zhang Yimou, Shadow (Ombra). La storia è ambientata in Cina nell’epoca dei Tre Regni (intorno al 220 d.c.) e prende le mosse dall’abitudine di re e nobili di farsi sostituire da sosia (le “ombre”) nei momenti di pericolo. Nel nostro caso, a farsi sostituire è il comandante di una città, chiamato dal sovrano della stessa a battersi contro il suo omologo di quella rivale, allo scopo di conquistarlo. Prima, durante e dopo la battaglia, la corte è funestata da intrighi di palazzo e vendette incrociate. Nulla da dire sulla fattura del film da un punto di vista tecnico, impreziosita dalla scelta del tono in grigio, che dà l’impressione del bianco e nero ed è perfetta per trasmettere allo spettatore un’atmosfera di dubbio, sfiducia e inganno. Ma è proprio questo clima di doppi giochi a non convincere: senza nessuna pretesa di spiegare la storia della Cina a un cinese, non ci si aspetta di vedere così poco senso dell’onore nel mondo orientale antico. L’unico personaggio al quale Zhang Yimou attribuisce la dignità di combattente valoroso è il generale della città da conquistare. Gli altri sono tutti infidi, privi di quel senso dell’onore che gli orientali antichi (cinesi o giapponesi che fossero) difendevano a costo di sacrificare la loro stessa vita. Tanto per capirci: un artificio come il Cavallo di Troia, simbolo dell’astuzia occidentale, un cinese non l’avrebbe mai adottato. Zhang Yimou racconta dunque una storia in cui di cinese, a parte i volti dei protagonisti e l’epoca storica, sembra esserci poco, come conferma anche una seconda parte tutta azione, in molti momenti inverosimile, che repentinamente prende il posto dell’introspezione della prima. Sintetizzandolo in una riga, potrebbe essere definito un film interessante per molti aspetti, ma non convincente per molti altri.
 Ultimo lavoro degno di nota degli ultimi due giorni di Festival è l’interessantissimo (e a dir la verità un po’ noioso per la ripetitività) documentario del regista ungherese Sergei Loznitsa, Process (The trial). Racconta minuziosamente, attraverso materiale d’archivio, lo svolgimento di uno dei tanti processi sovietici con imputazioni create ad arte da Stalin per trovare dei colpevoli o eliminare i dissidenti. In questo caso siamo nel 1930 e alla sbarra finiscono i membri di un’organizzazione controrivoluzionaria nemmeno esistente – il Partito Industriale – i quali si autoaccusano di crimini ovviamente mai commessi e vengono condannati a dieci anni di carcere o alla fucilazione poi convertita in reclusione. Vengono mostrate scene agghiaccianti, non soltanto nello svolgimento di un processo dove l’accusato non ha quasi nessuna possibilità di difendersi (peraltro è impossibile difendersi da un’accusa inventata), ma soprattutto nella fomentazione di un sentimento popolare che culmina nell’applauso scrosciante alla richiesta di una condanna a morte per tutti gl’imputati da parte del pubblico ministero. Dopo aver visto questo documentario fa ancora più specie il pensiero che i crimini sovietici siano stati tenuti nascosti tanto a lungo e che molte persone abbiano avuto fino a poco tempo fa, in ogni parte del mondo, il mito dell’ideologia comunista.
Ultimo lavoro degno di nota degli ultimi due giorni di Festival è l’interessantissimo (e a dir la verità un po’ noioso per la ripetitività) documentario del regista ungherese Sergei Loznitsa, Process (The trial). Racconta minuziosamente, attraverso materiale d’archivio, lo svolgimento di uno dei tanti processi sovietici con imputazioni create ad arte da Stalin per trovare dei colpevoli o eliminare i dissidenti. In questo caso siamo nel 1930 e alla sbarra finiscono i membri di un’organizzazione controrivoluzionaria nemmeno esistente – il Partito Industriale – i quali si autoaccusano di crimini ovviamente mai commessi e vengono condannati a dieci anni di carcere o alla fucilazione poi convertita in reclusione. Vengono mostrate scene agghiaccianti, non soltanto nello svolgimento di un processo dove l’accusato non ha quasi nessuna possibilità di difendersi (peraltro è impossibile difendersi da un’accusa inventata), ma soprattutto nella fomentazione di un sentimento popolare che culmina nell’applauso scrosciante alla richiesta di una condanna a morte per tutti gl’imputati da parte del pubblico ministero. Dopo aver visto questo documentario fa ancora più specie il pensiero che i crimini sovietici siano stati tenuti nascosti tanto a lungo e che molte persone abbiano avuto fino a poco tempo fa, in ogni parte del mondo, il mito dell’ideologia comunista.
Con questo film si chiudono le nostre cronache dal Festival di Venezia. Appuntamento a domani per i nostri pronostici sui vincitori e per un riassunto semiserio di questi 12 giorni.
Di seguito il trailer originale di Shadow:
© Riproduzione riservata