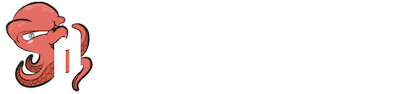Voto: 6/10 Titolo originale: If I Had Legs I'd Kick You , uscita: 10-10-2025. Budget: $1,500,000. Regista: Mary Bronstein.
If I Had Legs I’d Kick You: la recensione del thriller materno di Mary Bronstein
21/10/2025 recensione film If I Had Legs I'd Kick You di William Maga
La regista costruisce un dramma psicologico feroce e claustrofobico, impreziosito dall’intensità di Rose Byrne

If I Had Legs I’d Kick You è uno dei titoli più discussi passati al Sundance 2025: un film che prende la maternità e la trasforma in un’esperienza sensoriale, convulsa, a tratti comica e spesso terrificante. Mary Bronstein mette la macchina da presa incollata al volto di Linda (una Rose Byrne mai così brava, giustamente premiata a Sitges) e costruisce attorno a lei un labirinto di ostacoli: una figlia malata alimentata tramite sonda, un marito in mare aperto “per lavoro”, una casa che letteralmente si apre in un buco nero nel soffitto, un dottore inflessibile, un terapista irritato, una paziente che sfiora il collasso materno, un motel fuori stagione a Montauk che diventa purgatorio quotidiano.
L’idea potente è ridurre la figlia a presenza acustica e frammenti visivi: piedi, ciocche di capelli, la pompa dell’alimentazione che ticchetta come un metronomo dell’ansia. Lo sguardo non è sul “caso clinico” ma sullo stato mentale di una madre che confonde guasti domestici, colpe interiori e minacce esterne in un unico, ininterrotto cortocircuito.
Sul piano formale il film parte altissimo e resta in apnea: primi piani ostinati, suono che punge (il ronzio medicale diventa colonna ansiogena), inserti visionari – l’“apertura” nel soffitto che cola e si dilata, eco della ferita della bambina – e una regia che schiaccia ogni episodio sullo stesso livello di emergenza. Qui sta la sua originalità e insieme il suo rischio.
L’intenzione è chiara: quando si è stremati, tutto pesa allo stesso modo. Ma questa scelta, coerente con l’idea, produce anche un senso di saturazione che alcuni spettatori vivranno come immersione necessaria e altri come accanimento. L’andamento è quello di un unico giorno interminabile, dove un parcheggiatore ostile vale quanto una minaccia medica, una discussione telefonica pesa come una catastrofe domestica, il capriccio di un criceto diventa spavento slapstick e ferita insieme.
La Byrne regge l’impianto con una prova fisica e nervosa: occhi sempre sul punto di cedere, parola che inciampa, corpo che rifiata solo negli scarti grotteschi. Non cerca simpatia, esige vicinanza. È una madre che lavora come psicoterapeuta ma non trova spazio per la propria igiene emotiva; un personaggio sgradevole e tenero, comico senza volerlo, capace di far coincidere vergogna e furore.
 Accanto a lei, piccoli contrappunti che aprono spiragli d’aria: Conan O’Brien, glaciale terapeuta che ne esaspera l’isolamento; Danielle Macdonald, detonatore di panico materno; A$AP Rocky, portinaio del motel, presenza gentile che prova a farla “uscire da sé” tra chiacchiere notturne e derive autodistruttive. Sono figure-argine che però non reggono la piena: prima o poi anche loro vengono travolti dalla spirale.
Accanto a lei, piccoli contrappunti che aprono spiragli d’aria: Conan O’Brien, glaciale terapeuta che ne esaspera l’isolamento; Danielle Macdonald, detonatore di panico materno; A$AP Rocky, portinaio del motel, presenza gentile che prova a farla “uscire da sé” tra chiacchiere notturne e derive autodistruttive. Sono figure-argine che però non reggono la piena: prima o poi anche loro vengono travolti dalla spirale.
Narrativamente la Bronstein affila tre mosse. La prima è l’elusione: niente diagnosi della figlia, niente spiegoni sulle origini del crack coniugale, tutto filtrato dalla percezione. La seconda è il raddoppio simbolico: il buco nel soffitto come ferita che non si chiude, come portale sul vuoto, come oggetto mentale che inghiotte ogni pensiero. La terza è la torsione grottesca: episodi che sfiorano il comico e subito svoltano nell’angoscia, come a dire che il riso è solo un riflesso nervoso della paura.
Il film funziona proprio quando tiene insieme questi piani: realismo domestico, incubo simbolico, ironia nera. Vacilla quando insiste a lungo sul registro unico dell’allarme, schiacciando le gradazioni emotive e rendendo prevedibile l’onda d’urto. L’ultima parte cerca una via d’uscita in una scelta di corpo e di gesto che sposta il baricentro verso un esito più “dolce”: qualcuno lo sentirà come atto di grazia, altri come cesura costruita. Resta coerente l’idea che la soluzione non sia rassicurante, ma un accomodamento momentaneo con il caos.
Sul versante tecnico l’insieme è compatto e incisivo. La fotografia predilige 35mm e penombre lattiginose, trasformando Montauk fuori stagione in una zona liminale; la scelta di restare addosso a Byrne crea claustrofobia ma anche ritmo interno, con rari campi larghi usati come scosse. Il suono è la vera arma: allarmi medici, gocciolii, ventilazioni, rumori domestici amplificati fino a diventare allucinazioni uditive. La musica entra poco e di taglio, con canzoni-culla che suonano come presagi. Anche la direzione degli attori minori è calibrata su una sottile dissonanza: ogni incontro è una piccola frizione narrativa che non risolve mai, solo accumula.
Dal punto di vista tematico, If I Had Legs I’d Kick You è una radiografia della colpa materna contemporanea: l’aspettativa sociale di essere infallibili, l’assenza maschile benedetta dalla retorica del “lavoro”, la medicalizzazione del quotidiano, l’auto-sorveglianza senza tregua. La scelta di non “mostrare” la figlia è radicale: non disumanizza, al contrario rifiuta la pornografia del dolore infantile e ci costringe a vedere la bambina come proiezione della mente di Linda, cioè il punto in cui amore e panico diventano indiscernibili.
Il film è tanto più convincente quando resta in questa zona grigia e rifiuta etichette; meno quando inserisce motivi allegorici un po’ insistiti o quando, per alzare la posta, estremizza le singole situazioni fino alla soglia del compiacimento.
Nel confronto con altri ritratti recenti di maternità ansiosa, questa opera spinge più in là l’identificazione sensoriale e riduce al minimo la distanza di osservazione. È il suo pregio e la sua trappola: un’immersione così totale chiede resistenza e, per oltre un’ora e cinquanta, può risultare logorante. Ma proprio lì sta la fermezza dell’autrice: non offrire valvole di sfogo se non attraverso il grottesco, farci respirare come respira Linda, a scatti, a singhiozzo, tra un tubo che suona e un soffitto che suda.
Insomma, una regista che non ha paura di sporcare il quadro, una protagonista al massimo delle possibilità, un dispositivo sensoriale che rende tangibile la fatica di tenere insieme casa, lavoro, cura, desiderio, paura. If I Had Legs I’d Kick You è una prova di cinema nervoso e preciso, che sa come ferire e quando arretrare, capace di lasciare segni anche dove la ripetizione toglie ossigeno. Non piacerà a chi cerca consolazione o diagnosi; interessa a chi vuole stare, senza filtri, dentro l’uragano.
In attesa di capire quando lo vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di If I Had Legs I’d Kick You:
© Riproduzione riservata