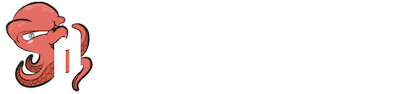Voto: 6/10 Titolo originale: 싸이보그지만 괜찮아 , uscita: 07-12-2006. Regista: Park Chan-wook.
Recensione story: I’m a Cyborg, But That’s OK di Park Chan-wook (2006)
09/01/2026 recensione film I'm a Cyborg, But That's OK di Gioia Majuna
Un film imperfetto, eccentrico e a tratti eccessivo, ma capace come pochi di trasformare la follia in tenerezza e l’amore in atto di resistenza

Con I’m a Cyborg, but That’s OK nel 2006 Park Chan-wook firmava uno dei suoi film più spiazzanti e, proprio per questo, più rivelatori: una storia d’amore in un istituto psichiatrico, luminosa e fantasiosa, attraversata da lampi di violenza immaginata e da un umorismo che fa ridere e poi fa sentire in colpa. Dopo la trilogia della vendetta, il regista sceglie il passo laterale: non un addolcimento, ma un cambio di fuoco, dove la crudeltà non è più solo un fatto, bensì un pensiero.
La trama si aggancia a un gesto estremo. Young-goon lavora in una fabbrica che pare uscita da un futuro d’altri tempi: nastri, transistor, altoparlanti, un ordine meccanico che somiglia a una gabbia. Una voce la spinge a farsi del male e a “collegarsi” alla corrente; lei crede di essere un cyborg, inviato sulla Terra per una missione. Ricoverata, parla con lampadine, distributori e orologi, indossa la dentiera della nonna e rifiuta il cibo perché, nella sua logica, l’organico corrompe i circuiti. L’energia deve arrivare dall’elettricità, non dalla cucina.
Nel reparto incontra Il-sun, cleptomane che sostiene di poter rubare qualunque cosa, perfino una qualità dell’anima. Con maschere artigianali e un’aria da mimo malinconico, scivola tra i pazienti come un ladro gentile. Si accorge subito che la scelta di non mangiare sta spegnendo Young-goon e decide di salvarla senza negarle il suo mondo. È qui che il film trova il suo cuore: non la “cura” come correzione, ma la cura come ascolto, anche quando ciò che si ascolta è una fantasia.
Park rifiuta la via più comoda, quella del personaggio “sano” che ci guida nel caos. Medici e infermieri restano sullo sfondo; in primo piano ci sono deliri, compulsioni, paure. È una scelta coraggiosa e rischiosa, perché può trasformare la sofferenza in una sfilata di stranezze. E in effetti il film flirta spesso con la caricatura: diversi ricoverati sono definiti da un solo tratto e usati come trovate comiche visive. Con la sensibilità odierna sulla salute mentale, questa leggerezza può risultare datata, anche quando l’intenzione è affettuosa: a volte sembra che il reparto diventi un palcoscenico di numeri, più che una comunità di persone.
A tenere insieme l’equilibrio, però, c’è Lim Soo-jung. Con parrucca nera, sopracciglia sbiancate e sguardo fisso, evita che Young-goon diventi una macchietta. La sua ostinazione ha un prezzo fisico, e il corpo che si assottiglia rende credibile la minaccia. Rain sorprende per misura: Il-sun è un ragazzo ferito che trasforma il trauma in gioco, e la sua protezione non è paternalismo, ma alleanza. La scena in cui “installa” un convertitore di riso nel corpo di lei è insieme inquietante e tenera: un trucco per farla mangiare senza umiliarla, il primo atto di fiducia che qualcuno le conceda sul serio.
Sul piano formale Park è in controllo. I titoli di testa sono un piccolo esercizio di stile, le inquadrature usano il reparto come una scatola di giocattoli, i colori pastello rendono l’istituto un luogo sospeso tra fiaba e prigione. Gli effetti digitali sono più frequenti di quanto si noti: radiografie, voli, trasformazioni, fantasie belliche. Qualcosa oggi tradisce l’età con una morbidezza dell’immagine e qualche artificio meno pulito, ma l’insieme resta coerente perché l’eccesso è sempre funzionale alla mente di chi vede il mondo in modo diverso.
Girato con una tecnologia HD allora pionieristica e poi riversato su pellicola, conserva una grana morbida. Anche la musica, spesso in ritmo da valzer, accompagna le trovate comiche e rende più lieve l’angoscia, a tratti.
Il limite maggiore sta nella durata e nella struttura a quadri. Il film è costruito per incidenti e variazioni, e a tratti si avverte la ripetizione del tema: la stessa idea viene ribadita con un altro scherzo, un altro sogno, un’altra trovata. Alcune deviazioni allungano il passo, i raccordi diventano visibili, e la tensione legata al rischio di morte per inedia si sfilaccia proprio quando dovrebbe mordere. Non è un crollo, ma un tratto in cui la narrazione gira a vuoto prima di ritrovare slancio.
Eppure questa libertà permette le sorprese migliori: una sparatoria immaginaria che è insieme vendetta e difesa, un volo che trasforma un letto in veicolo di fuga, un numero musicale che riassume desiderio e vergogna. Sono momenti che ricordano come Park sappia essere decorativo senza essere vuoto: ogni abbellimento è un modo per dire qualcosa sul bisogno di un posto nel mondo. Young-goon desidera una missione chiara come quella delle macchine, Il-sun desidera un legame che non lo giudichi.
Come opera “difficile da vendere”, I’m a Cyborg, but That’s OK paga la propria anomalia: non è il Park dei coltelli, ma nemmeno un passatempo. È una fiaba contemporanea che usa la follia come linguaggio figurato e rischia fraintendimenti. Il finale sceglie la quiete: niente trionfo, solo la possibilità di stare accanto a qualcuno condividendo una verità imperfetta. Ed è forse la sua scelta più radicale: sostituire la vendetta con la cura, senza fingere che l’amore risolva tutto.
Il trailer di I’m a Cyborg, But That’s OK:
© Riproduzione riservata