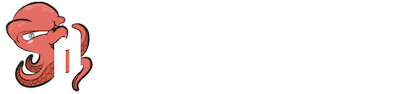Voto: 6.5/10 Titolo originale: Gueules noires , uscita: 15-11-2023. Regista: Mathieu Turi.
The Deep Dark: la recensione del film horror francese di Mathieu Turi
06/10/2025 recensione film The Deep Dark - Discesa nell'abisso di William Maga
Il regista unisce terrore, critica sociale e mitologia sepolta in un viaggio negli abissi della paura

The Deep Dark – Discesa nell’Abisso è un film dell’orrore sotterraneo che indossa molti volti: racconto di classi, parabola coloniale, avventura di sopravvivenza, mitologia arcaica. Proprio in questa stratificazione sta la sua forza principale e il suo rischio più evidente. Da un lato la messa in scena in miniera nel 1956 – con turni massacranti, rivalità etniche e gerarchie salariali – conferisce densità storica e sociale; dall’altro l’intreccio, quando decide di scatenare il “numinoso” che abita le gallerie, spinge sull’acceleratore di sangue e ferocia fino a lambire il compiacimento.
L’innesco drammatico è classico: un gruppo di minatori viene trascinato sempre più in basso da un professore benestante in cerca di reperti “indispensabili”. Ma la classicità del canovaccio è riscattata dall’angolazione scelta. Amir (Amir El Kacem), marocchino francofono, è il nostro sguardo: novizio del sottosuolo, cuscinetto linguistico e culturale, bersaglio di diffidenze. La sua traiettoria personale – intelligenza soffocata da un sistema che lo vuole braccia, non testa – dà al film un cuore umano che molte opere sorelle non possiedono. In contrappunto, il professor Berthier (Jean-Hugues Anglade) condensa il lato predatorio del potere: decide, occulta, sacrifica. Non c’è predica, c’è drammaturgia: ogni scelta “scientifica” costa sangue a chi scava.
Sul piano del genere, il confronto inevitabile è con il cinema ‘con grotta claustrofobica’. Qui l’ansia non nasce dai balzi improvvisi, ma da luce e buio usati come lame. Torce, carburi, lampade frontali disegnano volumi, cancellano vie di fuga, rivelano solo quel tanto che basta a immaginare il resto. Memorabile la soluzione delle lampadine a flash: ogni scatto congela per un istante la distanza fra vita e morte, come una danza stroboscopica con l’ignoto. La geografia del dedalo è chiara: si capisce dove sono i personaggi, quanto si allontanano, quanto si perdono. In tempi di montaggi frullati è un pregio non comune.
Il mostro – vero baricentro emotivo dell’opera – è concepito con artigianato fisico: protesi, meccanica, sudore di reparto. Si intravedono echi di immaginari celebri, ma la creatura mantiene un’identità propria, massiccia, multilimbica, quasi corazzata, capace di imprimersi nella memoria. L’uso misurato della grafica digitale serve a cucire, non a sostituire. Anche quando la violenza esplode e gli arti volano, l’impatto resta concreto, tattile, “di peso”. Una sequenza con il cavallo sfiora l’allucinazione, eppure resta coerente con il tono sensoriale del film.
Dove il racconto traballa è nel ritmo dell’attesa. Dopo un prologo d’epoca che promette abissi, la discesa vera arriva tardi e alcuni personaggi di contorno restano silhouettes che, coperte di polvere e sangue, faticano a distinguersi. La scelta di privilegiare Amir e il duello etico con il professore ha senso, ma impoverisce l’insieme quando la conta dei caduti accelera: più partecipiamo al destino di chi muore, più l’orrore pesa; qui, a tratti, il coinvolgimento si assottiglia.
Altra frizione: l’allegoria. L’entità che si risveglia sembra un dio vorace, antico come la pietra e moderno come il capitale: chiede tributi, divora manodopera, punisce la hybris di chi scava troppo. È una metafora potente, eppure il film oscilla fra l’idea cosmica (la mostruosità come legge del mondo) e la funzione narrativa (la mostruosità come motore di inseguimenti e squartamenti). Quando prevale la seconda, la poesia nera dell’insieme si fa più rumorosa che inquietante.
Resta però il pregio scenografico: gallerie reali, curve impreviste, passaggi che dal naturale scivolano nel costruito, murature antiche incise di segni, pitture rupestri che annunciano culti e catastrofi. Ogni svolta di cunicolo è una svolta di senso: dalle ossa alla storia, dalla storia al mito, dal mito alla macelleria. La colonna sonora, più attenta ai respiri che ai temi, avvolge senza invadere; il suono dei crolli, delle pietre, delle flebo che gocciolano nel buio, è un’altra creatura che stringe alla gola.
Sul versante “politico”, l’opera parla chiaro senza proclami. La miniera è crogiolo e coltello: francesi, italiani, spagnoli rivendicano patrie e sudori ma temono il “nuovo venuto” più economico. Intanto chi comanda muove pedine, compra complicità, taglia angoli di sicurezza. Che il primo peccato sia di avidità – rubare un reperto, forzare una cripta, monetizzare il sacro – non è casuale. Nel sottosuolo, la cupidigia è sempre un detonatore.
Il finale non reinventa la ruota, ma chiude con coerenza il discorso morale: ciò che è stato dissotterrato non è solo un organismo, è un ordine del mondo che pretende sacrifici. L’idea che “non debba mai raggiungere la superficie” suona come un monito doppio: trattenere la bestia e trattenere la logica che l’ha creata. Qui The Deep Dark – Discesa nell’Abisso si fa davvero senza tempo: parla del 1956, ma riguarda i nostri scavi attuali – letterali e simbolici.
In sintesi, The Deep Dark – Discesa nell’Abisso è una prova solida di cinema horror europeo: atmosfera, artigianato, un protagonista che si fa voler bene, un antagonista che incute rispetto, un contesto sociale che respira. Difetti? Qualche lentezza iniziale, figure secondarie poco cesellate, alcune esplosioni truculente che schiacciano l’ambiguità mitica. Pregi? Fotografia che scolpisce il buio, effetti pratici memorabili, regia che sa orientare e comprimere lo spazio, sottotesto di classe e colonialismo che punge senza prediche. Non è la miniera più originale del decennio, ma è una caverna in cui vale la pena calarsi, con la torcia ben salda e il respiro corto.
Di seguito trovate il trailer internazionale di The Deep Dark – Discesa nell’Abisso:
© Riproduzione riservata