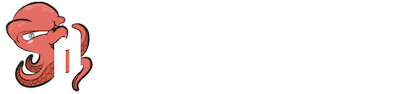Titolo originale: The Life of Chuck , uscita: 05-06-2025. Budget: $25,000,000. Regista: Mike Flanagan.
The Life of Chuck: spiegazione del finale e analisi del realismo magico di Mike Flanagan
24/09/2025 news di Gioia Majuna
Guida all'interpretazione dell'adattamento di Mike Flanagan

The Life of Chuck è uno dei più audaci adattamenti da Stephen King: un film che procede al contrario, in tre atti rovesciati, per dirci che la fine del mondo non è altro che la fine di un mondo interiore. Mike Flanagan abbandona l’orrore esplicito per un racconto esistenziale, dove Tom Hiddleston presta volto e misura a un uomo qualunque che scopre di “contenere moltitudini” (la recensione).
Struttura rovesciata: perché il film parte dalla fine
L’apocalisse dell’atto iniziale – cartelloni con “39 anni splendidi. Grazie, Chuck!”, reti in blackout, voragini, città che cedono – non è il collasso dell’universo fisico, ma la progressiva chiusura della coscienza di Chuck, malato di tumore. È il suo “mondo mentale” che si spegne: popolato da volti incontrati di sfuggita, luoghi sedimentati nella memoria (la casa dei nonni, la scuola, la strada), professioni evocate (il necroforo, il medico, l’insegnante). Le figure decisive della vita reale, invece, rimangono fuori da quel teatro apocalittico e riappaiono solo al capezzale: è lì che affiorano la moglie e il figlio, ancorando la verità affettiva all’ultimo sguardo sul mondo.
Raccontando al contrario, il film trasforma il “mistero” iniziale in chiave interpretativa: quando arriviamo all’infanzia, capiamo che l’epilogo cosmico era metafora. E che The Life of Chuck è, in realtà, un’opera sulla vita, non sulla morte.
 Il cuore del film: la danza come etica del presente
Il cuore del film: la danza come etica del presente
Il movimento centrale spezza il buio con un improvviso atto di gioia: Chuck si lascia trascinare da un ritmo di strada e balla. Non è un intermezzo decorativo: è il manifesto etico del film. Il corpo che risponde alla musica afferma una cosa semplice e radicale: il presente va abitato, perché il domani è incerto. Dentro quella vitalità si insinua l’ombra della malattia, ma proprio per questo quel gesto diventa prezioso: carpe diem senza retorica, cura di sé e degli altri attraverso l’energia condivisa.
La cupola: stanza proibita e responsabilità dello sguardo
Nell’atto conclusivo (cronologicamente il primo), la cupola in cima alla casa dei nonni – stanza chiusa, quasi “divina” per posizione e mistero – ospita la visione fondativa: il ragazzo intravede la propria morte. La rivelazione potrebbe condannarlo all’angoscia; invece produce una scelta morale: decidere di vivere, nonostante tutto. La cupola è il simbolo del segreto custodito: sapere che il tempo è finito non deve paralizzare, ma misurare ogni istante.
“Io sono vasto, contengo moltitudini”: il senso ultimo
Il verso di Walt Whitman esplicitato nel film offre la griglia di lettura: ciascuno di noi costruisce nel tempo un cosmo privato fatto di relazioni, ricordi, dettagli minimi; quando una persona muore, quel cosmo crolla. Ma ciò non svuota di senso i mondi degli altri: al contrario, ribadisce che ogni vita ordinaria è straordinaria nella sua rete di connessioni. Per questo la prima parte è colma di rimandi: persone e luoghi riemergono come echi del vissuto di Chuck, non come citazioni compiaciute.
Flanagan, King e l’orrore della realtà
Flanagan rilegge King portando i suoi temi ricorrenti – lutto, tempo, memoria, responsabilità – in un realismo magico che respira cinema puro: la struttura a ritroso orienta lo sguardo, il montaggio per rime avvicina epoche e volti, la musica sostiene l’onda emotiva senza schiacciarla. Ne esce un’opera che parla della fine per riaffermare la cura del presente; che mostra l’abisso, ma invita a scegliere la danza.
Perché funziona (e perché rivederlo)
La spiegazione del finale non è un trucco: è un patto narrativo che ti obbliga a ripensare ogni immagine. La connessione tra i tre atti è sensibile, non didascalica: riconosci i fili quando decidi di ascoltare. Il film valorizza l’ordinario: una lezione di ballo, un corridoio di scuola, un cartellone sulla tangenziale diventano coordinate cosmiche.
The Life of Chuck è, in ultima analisi, un invito a vivere: accettare che il mondo finirà “con noi” non per disperare, ma per dare peso a ciò che amiamo ora. È anche per questo che funziona meglio alla seconda visione: quando conosci il segreto della cupola, ogni dettaglio si illumina.
Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Life of Chuck:
© Riproduzione riservata