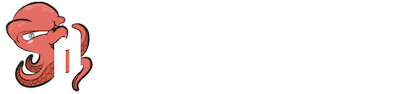Voto: 5/10 Titolo originale: Ænigma , uscita: 30-12-1987. Regista: Lucio Fulci.
Recensione story: Aenigma di Lucio Fulci (1987)
24/08/2025 recensione film Aenigma di William Maga
Tra influenze di Carrie e Patrick, atmosfere paranormali, limiti produttivi e la celebre scena delle lumache, un horror di transizione che racconta il declino e l’inventiva del maestro

Aenigma del 1987 è uno dei casi più istruttivi per capire il tardo cinema di Lucio Fulci: un film che nasce sotto il segno del riciclo e finisce, nonostante tutto, per rivelare un residuo di potenza figurativa. La trama è quella di un gotico scolastico travestito da vendetta paranormale: Kathy, studentessa umiliata dalle compagne e ridotta in coma dopo uno scherzo crudele, canalizza la propria furia attraverso Eva, nuova allieva che prende la sua stanza al collegio di St. Mary’s.
Da quel momento, i carnefici cadono uno a uno, mentre un medico distratto registra solo gli sbalzi dei parametri vitali della paziente. Il debito con Carrie (bullismo, umiliazione pubblica, rivalsa telecinetica) e con Patrick (il corpo immobilizzato che agisce a distanza) è palese, eppure non esaurisce il senso dell’operazione: Fulci sposta l’asse dall’“evento” al dispositivo, facendo del doppio Kathy/Eva il vero campo di battaglia.
Il meccanismo del doppelgänger funziona come lente su tre piani. Anzitutto quello sociale: il collegio “per bene” diventa teatro di una violenza di classe e di sguardo, dove la bellezza codificata decide chi è visibile e chi va sacrificato. Poi quello psichico: Eva è guscio e specchio, identità porosa che si lascia attraversare dal rancore dell’altra e lo rimanda amplificato. Infine quello materno: la presenza di Mary, la madre-guardiana che pulisce i corridoi e veglia in ospedale, introduce un sentimento di protezione rovesciato in complicità muta, quasi una benedizione del castigo. È qui che il film, pur nell’economia di mezzi e nelle scorciatoie di scrittura, trova un cuore ambiguo: non chiede di credere alla psicocinesi, ma al peso concreto della vergogna e al suo ritorno.
Sul versante della messa in scena, Aenigma alterna pigrizie e guizzi. La fotografia è spesso piatta, gli interni portano addosso l’aria di location adattate in fretta, la recitazione risente di un casting disomogeneo e di dialoghi elementari. Ma quando Fulci inquadra la punizione, l’automatismo si spezza: la statua che schiaccia, lo specchio che duplica e tradisce, l’incubo che scivola nel reale. E soprattutto la celebre morte “delle lumache”: una trovata che potrebbe precipitare nel ridicolo, e invece, per come è preparata e girata, si imprime come un incubo viscoso, quasi un contrappasso organico alla morbidezza delle compagne “perbene”. Non è il compiacimento sanguinolento dei suoi picchi di inizio decennio; è una crudeltà più laterale, che preferisce l’idea all’eccesso.
 La struttura è lineare e questo è insieme limite e scelta: niente labirinti temporali, pochi depistaggi, un percorso di colpa e pena che procede per quadri, come in un racconto morale travestito da horror scolastico. Qui emergono i veri vuoti: il rapporto tra Eva e Kathy resta più intuito che indagato; la relazione con il medico, pensata per introdurre un contrappunto sentimentale, non genera scintille e spesso produce solo scene di riempimento; alcuni comprimari esistono per arrivare al loro destino senza davvero incidere sull’atmosfera. Eppure, la semplicità della trama consente a Fulci di concentrare l’energia su due o tre idee-chiave e su un paio di sequenze che bastano a dare al film una fisionomia.
La struttura è lineare e questo è insieme limite e scelta: niente labirinti temporali, pochi depistaggi, un percorso di colpa e pena che procede per quadri, come in un racconto morale travestito da horror scolastico. Qui emergono i veri vuoti: il rapporto tra Eva e Kathy resta più intuito che indagato; la relazione con il medico, pensata per introdurre un contrappunto sentimentale, non genera scintille e spesso produce solo scene di riempimento; alcuni comprimari esistono per arrivare al loro destino senza davvero incidere sull’atmosfera. Eppure, la semplicità della trama consente a Fulci di concentrare l’energia su due o tre idee-chiave e su un paio di sequenze che bastano a dare al film una fisionomia.
La musica di Carlo Maria Cordio accompagna questo doppio registro. L’avvio con una canzone leggera, quasi fuori luogo, annuncia una dissonanza che il resto della partitura ricompone con tappeti elettronici più cupi, capaci di sostenere i passaggi onirici e l’inquietudine diffusa. È un commento sonoro che non nobilita a tutti i costi, ma a tratti sfiora la grazia, soprattutto quando deve coprire l’economia delle immagini.
Rispetto ai classici cui guarda, Aenigma perde in coerenza e profondità psicologica, ma guadagna in erranza, in quella libertà del cinema di genere italiano di fine anni Ottanta che mescola suggestioni senza preoccuparsi troppo della purezza delle fonti. Non è un omaggio, non è una citazione colta: è una pratica di sopravvivenza. Da un lato c’è il declino materiale (budget contratti, tempi rapidi, scenografie spoglie); dall’altro, una testarda volontà di invenzione. Fulci non reinventa il proprio cinema, ma ne salva il gesto: l’idea che un’inquadratura possa ancora ferire, anche quando tutto intorno sembra sbiadire.
Per questo Aenigma è un titolo di passaggio più che “minore”. È discontinuo, derivativo, a tratti ingenuo; e tuttavia conserva un nucleo disturbante, una riflessione elementare e precisa su come lo sguardo ferisca e su come la ferita ritorni. Anche quando inciampa in scelte facili o in attori spaesati, il film insiste su quella linea sottile dove il grottesco diventa inquietudine. Non appartiene all’olimpo del regista, ma non merita nemmeno l’oblio: è un tassello che racconta una fase, un modo di fare horror con poche risorse e un’ostinazione d’autore che, a sprazzi, ancora abbaglia. In questo sta la sua discreta forza e la ragione per cui, a distanza di anni, lo si continua a ricordare: non per la perfezione, ma per l’immagine che punge.
Di seguito trovate il trailer di Aenigma:
© Riproduzione riservata