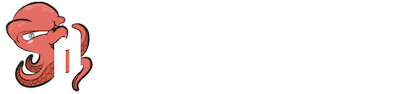Voto: 6/10 Titolo originale: La grazia , uscita: 05-12-2025. Budget: $24,500,000. Regista: Paolo Sorrentino.
La Grazia: la recensione del film presidenziale di Paolo Sorrentino
01/09/2025 recensione film La grazia di Giovanni Mottola
Il regista si affida ancora a Toni Servillo per il ritratto di un presidente della Repubblica sospeso tra dubbi, eutanasia e fantasmi del passato

In un contesto come la Mostra di Venezia, la giornata di un recensore può risultare anche più impegnativa di quella di uno scrutatore. Certo, è sempre meglio che lavorare, come sosteneva Barzini. Però il calendario delle proiezioni riservate alla stampa prevede che egli, appena alzato, si rechi subito a vedere due film del Concorso, uno dopo l’altro, il primo alle 8.30 circa e il secondo alle 11-11.30 circa.
Quando ormai si sono fatte quasi le due e la gente normale ha messo le gambe sotto il tavolo, il recensore è costretto a saltare il pasto, o abborracciarlo alla bell’e meglio, per correre in sala stampa (i posti sono limitati ma la concorrenza no) a scrivere i pezzi sui film appena visti, affannandosi per mandarli in redazione senza essere battuto sul tempo dai colleghi.
Tutto questo per parlare di film che, ammesso escano poi in sala, potrebbero farlo dopo alcuni mesi. Riflettendoci bene, chi scrive di cinema per professione deve dunque elaborare in pochi minuti dalla visione un giudizio su un’opera che, contandone concepimento e parto, può aver comportato mesi o addirittura anni di lavorazione. La recensione, per i motivi detti, non può che essere scritta sul tamburo.
Eppure, a chiunque pensi che un film sia qualcosa di più della somma dei suoi aspetti tecnici – trama, interpretazione, regia, fotografia, montaggio, colonna sonora – risulterà a questo punto chiaro che un pezzo siffatto non consente di cogliere il senso profondo dell’opera a chi lo legge, per il semplice motivo che non l’ha potuto cogliere, a monte, chi l’ha scritto.
Questo rapporto tra tempo e azione è stato analizzato spesso anche in letteratura, in modi seri o faceti, ma senza arrivare a una risposta definitiva. Il Giudice Bridoye, quel personaggio del Gargantua e Pantagruel che decideva le cause tirando i dadi per esorcizzare l’alea del processo, sosteneva che i fascicoli andassero lasciati a stagionare come se fossero prosciutti.
Al tempo stesso si potrebbe però affermare quel che sosteneva Friedrich Durrenmatt a proposito della testimonianza. Secondo lo scrittore svizzero, tanto profondo quanto arzigogolato nei ragionamenti, essa è inevitabilmente sempre falsa proprio a causa del tempo che intercorre rispetto al fatto su cui si deve deporre. Chi ad esso assiste non può infatti avere contezza, salvo casi eccezionali, di dover fissarlo nella propria memoria perché in futuro gliene verrà chiesto conto con precisione, quindi il ricordo sarà già di per sé fallace. Inoltre, il tempo che passa provvede a inquinarlo ulteriormente, finendo spesso col creare confusione tra l’effettivamente accaduto e quel che si crede di aver veduto sulla base del proprio desiderio.
 Questi dilemmi sulla necessità o meno di ponderare le questioni non sono il frutto di deliri personali, ma della visione de La Grazia di Paolo Sorrentino, il pezzo da novanta tra i cinque film italiani in gara. Esso propone infatti allo spettatore la figura di un Presidente della Repubblica (Toni Servillo) roso da una serie di dubbi che ne condizionano profondamente l’agire, finendo per ripercuotersi sullo spettatore, il quale a sua volta ne sviluppa di propri.
Questi dilemmi sulla necessità o meno di ponderare le questioni non sono il frutto di deliri personali, ma della visione de La Grazia di Paolo Sorrentino, il pezzo da novanta tra i cinque film italiani in gara. Esso propone infatti allo spettatore la figura di un Presidente della Repubblica (Toni Servillo) roso da una serie di dubbi che ne condizionano profondamente l’agire, finendo per ripercuotersi sullo spettatore, il quale a sua volta ne sviluppa di propri.
La vicenda si svolge durante il Semestre Bianco, cioè gli ultimi sei mesi del settennato presidenziale, quando al Capo dello Stato diventa precluso lo scioglimento delle Camere. Uomo vedovo, con due figli, soprannominato ‘Cemento Armato’ per via di un carattere duro e all’apparenza insensibile, sentendo avvicinarsi la fine della sua carriera politica avverte il dovere di prendere decisioni importanti su due argomenti: la firma su un progetto di legge che disciplini l’eutanasia e l’eventuale concessione della grazia a due assassini, una donna che ha ammazzato nel sonno il marito che la torturava e un uomo che ha ucciso la moglie afflitta da una forma avanzata di Alzheimer.
Materie su cui, almeno in teoria, nessuno sarebbe più ferrato del Presidente, insigne giurista di Diritto Penale, autore di ponderoso manuale. Ma la decisione non può basarsi soltanto su codici e pandette: serve, in primo luogo, lo slancio umano. Su questo tema s’incardinano gli scontri con la figlia (Anna Ferzetti), anch’essa giurista e sua principale collaboratrice, portatrice di una visione più progressista e sentimentale. In realtà anche nell’animo del Presidente i sentimenti hanno un peso importante, ma sotto forma di zavorra che si trascina dal passato.
Il film avrebbe potuto essere molto buono se si fosse limitato alla proposizione del dubbio. Invece lo scioglie, come già il titolo suggerisce (molto bello il doppio senso tra l’accezione giuridica e quella spirituale), ma lo fa nella direzione più scontata, finendo col banalizzarsi. Anche la sceneggiatura, mai stata il punto forte di Sorrentino, non brilla per originalità.
In particolare, risulta debole il ripetuto riferimento all’ossessione del Presidente per un tradimento di quarant’anni prima della moglie, rispetto al quale continua a tormentarsi per scoprirne l’amante. Questo finisce per danneggiare anche la figura più riuscita del film, l’amica d’infanzia Coco Valori (interpretata da un’ottima Milvia Marigliano). Entra in scena a una cena e spara a raffica una battuta più arguta dell’altra; però poi, essendo lei l’unica a conoscenza del segreto, il suo personaggio viene riproposto solo per trattare di quell’argomento, sacrificando così l’irresistibile ironia di cui sarebbe stata provvista.
Del tutto inutile tentare di riconoscere nel Presidente della Repubblica di Sorrentino uno dei reali interpreti del ruolo. Il regista ha riproposto la medesima tecnica utilizzata per strutturare i personaggi che contornano Berlusconi nel film Loro: rifarsi a molte persone reali, infondendo qualcosa di ciascuna nel singolo ruolo.
Democristiano come Scalfaro e Mattarella, roso da dubbi come lo fu Cossiga (pur non ancora Presidente) al tempo del sequestro Moro, giurista come praticamente tutti. Ancora una volta (è la settima) ha fatto ricorso a Toni Servillo, avendo trovato in lui da tempo il miglior interprete del suo cinema.
Entrambi portatori della tipica simpatia napoletana nella vita, non la ripropongono affatto nei film, dove prevale sempre l’aspetto tecnico-visivo per quanto riguarda la regia e una certa studiata freddezza nell’interpretazione. Meno barocca e onirica delle opere scritte insieme a Umberto Contarello, la Grazia contiene comunque alcune sorrentinate abituali, come per esempio la scena dell’arrivo del Presidente della Repubblica portoghese al Quirinale sotto la pioggia, o la sfilata di Servillo verso casa, accompagnato dalla scorta e da un cane robotico.
La costanza di queste trovate ci fornisce in fondo un vantaggio rispetto alle considerazioni che facevamo in apertura circa il problema di recensire un film a stretto giro dalla sua visione. Con Sorrentino possiamo scriverne subito senza problemi. Tanto, al netto di qualche differenza di trama, fa sempre lo stesso film con lo stesso attore.
Il trailer di La Grazia, che uscirà nei cinema il 15 gennaio 2026:
© Riproduzione riservata