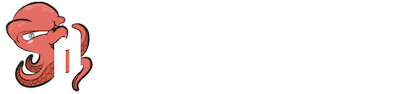Perché il cinema perde spettatori? Analisi di una crisi multiforme
01/07/2025 news di Stella Delmattino
La crisi del cinema tra streaming, disinteresse giovanile e distorsioni dell’industria: un’analisi sulle sfide che minacciano le sale italiane

Il grande schermo, un tempo santuario di sogni collettivi e fulcro pulsante della cultura popolare, vive oggi una fase di profonda e complessa trasformazione. Questo periodo di crisi vede un calo di spettatori nelle sale cinematografiche che è divenuto un fenomeno tangibile, costringendo a una riflessione non solo gli addetti ai lavori ma chiunque abbia a cuore la settima arte e la sua fruizione comunitaria.
Il declino assume contorni particolarmente netti se si osserva il disinteresse manifestato dalle fasce più giovani della popolazione, un tempo zoccolo duro del pubblico. Le ragioni di questa disaffezione sono molteplici e si diramano su due fronti principali: da un lato, una vera e propria rivoluzione digitale che ha stravolto le abitudini di fruizione dei contenuti audiovisivi; dall’altro, dinamiche interne all’industria cinematografica stessa, talvolta complesse e opache, che sembrano contribuire a un progressivo allontanamento del pubblico.
Le distrazioni digitali e il tramonto dell’esperienza collettiva: perché si va meno al cinema
L’esperienza cinematografica tradizionale, con i suoi riti e i suoi tempi, si scontra oggi con un ecosistema mediatico radicalmente mutato, che offre alternative immediate, personalizzate e spesso più economiche. L’era dello streaming e la comodità del salotto è forse il primo, e più evidente, fattore di questa trasformazione. L’impatto dirompente di piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e altre ancora è innegabile, avendo saputo intercettare, e per certi versi plasmare, le nuove esigenze degli spettatori.
Queste realtà offrono un catalogo virtualmente infinito di film, serie TV, documentari e produzioni originali, con vantaggi percepiti significativi: costi spesso inferiori rispetto al cumulo di spese per biglietto e consumazioni, l’accessibilità immediata da una miriade di dispositivi e, soprattutto, una personalizzazione dell’offerta che permette di scegliere cosa, come e quando guardare. La fruizione “on demand” ha liberato lo spettatore dai vincoli della programmazione in sala, trasformando il salotto di casa nel proprio cinema privato, una tendenza che attrae in modo particolare il pubblico più giovane, nativo digitale e abituato a una gratificazione istantanea.
A questa dinamica si aggiunge il ruolo preponderante assunto dallo smartphone: un universo in tasca che eclissa la sala cinematografica. Il cellulare è diventato l’epicentro della vita sociale, informativa e, in maniera crescente, dell’intrattenimento, specialmente per i giovani. Questo dispositivo multifunzionale, sempre a portata di mano, offre un flusso costante e ininterrotto di contenuti: dai social media, che frammentano l’attenzione, alla messaggistica istantanea, fino a un’infinità di video brevi che saturano il tempo libero.
In questo contesto, l’intrattenimento diventa una merce sempre disponibile, facilmente accessibile e spesso gratuita o a basso costo. Si pensi alla vasta gamma di videogiochi online o al mondo in espansione del gioco mobile, che include un ventaglio di opzioni capaci di assorbire tempo e risorse.
Questa iper-disponibilità di intrattenimento digitale ha trasformato radicalmente anche la fruizione domestica dei contenuti, rendendo comuni pratiche un tempo inimmaginabili. Se in passato l’idea di guardare un film e contemporaneamente giocare alle slot machine sarebbe parsa quasi surreale, oggi, con uno smartphone sempre a portata di mano mentre si guarda la TV di casa, questa sovrapposizione di attività è diventata per molti una possibilità concreta, quasi una banalità.
La conseguenza diretta di tale scenario è una frammentazione dell’attenzione e una crescente preferenza per esperienze di intrattenimento più brevi, parcellizzate e immediatamente fruibili. Questo modello di consumo mal si concilia con l’impegno, anche temporale, richiesto dalla visione di un film in sala, contribuendo al suo percepito declino come opzione primaria.
Di fronte a questa marea di stimoli digitali, il cinema, nella percezione contemporanea, rischia di passare da evento a una delle tante opzioni disponibili. Quello che un tempo era un rito, un’occasione speciale e un luogo privilegiato di aggregazione, oggi deve competere con una miriade di alternative più agili. Il bilancio tra costi effettivi e benefici percepiti pende sempre più di frequente a sfavore della sala, specialmente quando alternative valide sono accessibili a minor prezzo dal comfort domestico.
Dietro le quinte della crisi: le storture di un sistema cinematografico inceppato
Se le abitudini del pubblico sono cambiate, è altrettanto vero che la crisi del cinema affonda le sue radici in problematiche interne all’industria, in un “sistema che non funziona”, come talvolta descritto da chi indaga a fondo il settore. Queste disfunzioni, spesso poco note al grande pubblico, contribuiscono a indebolire l’intero settore, a partire proprio dalle sale, l’ultimo anello di una catena complessa.
La filiera cinematografica italiana, descritta metaforicamente come un albero di Natale da alcuni addetti ai lavori, si articola classicamente attraverso le figure di produttore, distributore, agente ed esercente. In teoria, una catena lineare; in pratica, un sistema dove ogni anello cerca di massimizzare il proprio profitto, con il rischio concreto che le criticità si scarichino sulla sala cinematografica, spesso la più esposta e con minori margini di manovra.
Particolarmente delicato e influente è il ruolo della distribuzione, il cui potere può generare dinamiche controverse. Esercenti hanno denunciato, spesso mantenendo l’anonimato per timore di ritorsioni, pratiche che suonano come veri e propri boicottaggi: veti incrociati tra distributori concorrenti che limitano drasticamente la libertà di programmazione delle sale. Se un esercente sceglie di lavorare con un determinato distributore, potrebbe vedersi precluso l’accesso ai film di un altro.
A ciò si aggiunge l’annosa questione dell’imposizione di “pacchetti” di film: per ottenere il blockbuster del momento, la sala è spesso costretta ad accettare anche titoli minori o meno appetibili, alterando la coerenza della propria offerta. La riduzione della “tenitura” dei film e la progressiva scomparsa delle sale di seconda o terza visione completano un quadro di difficoltà, scenario evidenziato anche da vicende legali come l’esposto all’antitrust del Cinema America di Roma.
Un altro elemento cruciale, e ambivalente, è il Tax Credit sulla distribuzione, un meccanismo fiscale pensato per incentivare il settore. Se da un lato ha portato benefici, come il sostegno al miglioramento delle sale, dall’altro, può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Esiste il rischio concreto di un utilizzo distorto: si assiste talvolta a un ingorgo di uscite legato alla scadenza dei benefici fiscali, o al fenomeno delle proiezioni fantasma.
Queste ultime vedono film distribuiti formalmente in poche copie e orari improbabili, non tanto per raggiungere il pubblico, quanto per soddisfare i requisiti di legge e accedere ai crediti d’imposta. Si configura così il paradosso di un rientro economico che può prescindere dal successo di pubblico, lasciando l’esercente come unico attore realmente interessato al risultato al botteghino. Tali pratiche possono alimentare, inoltre, zone grigie finanziarie, come accennato da testimonianze interne.
Infine, un ulteriore fattore di complessità è la concentrazione di potere e i potenziali conflitti d’interesse, che si verificano quando i diversi ruoli della filiera – produttore, distributore, agente e talvolta persino esercente – si fondono nella stessa entità o in gruppi strettamente collegati. Tale verticalizzazione può ulteriormente ridurre la concorrenza e la pluralità dell’offerta.
L’esercente cinematografico: tra passione e sopravvivenza in un mercato ostile
In questo scenario complesso, la figura dell’esercente cinematografico emerge spesso come l’anello più debole, un attore costretto a navigare a vista tra la passione per il cinema e le dure leggi di un mercato che presenta numerose storture. Molti esercenti si sentono soggetti passivi e danneggiati da un sistema che li penalizza.
Le sfide nel tentativo di offrire una programmazione di qualità, che sappia coniugare valore culturale e richiamo commerciale, diventano enormi quando l’autonomia decisionale è limitata da veti, imposizioni e dalla scarsità di prodotto realmente disponibile. Il paradosso dell’esercente è emblematico: è la figura più direttamente motivata al successo di pubblico di un’opera, poiché da quello dipende la sua sopravvivenza economica, ma si ritrova con margini di manovra sempre più ridotti, schiacciato tra le esigenze di un pubblico che cambia e le rigidità di un’industria che fatica a riformarsi.
La crisi del cinema è, dunque, il risultato di un intreccio complesso di fattori. Da un lato, assistiamo a una profonda trasformazione delle abitudini di consumo culturale, accelerata dalla tecnologia mobile e dalla pervasività dell’intrattenimento digitale individuale, che hanno ridefinito tempi e modi della fruizione.
Dall’altro lato, emergono con chiarezza le disfunzioni interne di un’industria cinematografica che, almeno in Italia, sembra a tratti avvitarsi su se stessa. Meccanismi non sempre orientati a premiare il merito artistico o il gradimento del pubblico, ma piuttosto logiche di rientro dell’investimento che possono prescindere da esso, contribuiscono a questo stato di sofferenza.
Diventa quindi urgente superare la logica superficiale dei capri espiatori per affrontare con lucidità e coraggio le problematiche strutturali che affliggono il settore. Solo una riflessione profonda, seguita da riforme concrete che promuovano la trasparenza, l’equità nella filiera e un reale sostegno alla diversità dell’offerta, potrà forse gettare le basi per un futuro in cui si possa riscoprire e rivitalizzare il valore unico e insostituibile dell’esperienza cinematografica collettiva in sala, un’esperienza che merita di essere difesa e valorizzata, per il bene del cinema e del suo pubblico.
© Riproduzione riservata