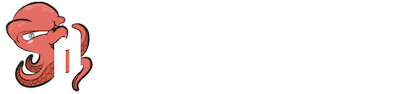Voto: 5/10 Titolo originale: Drive-Away Dolls , uscita: 22-02-2024. Budget: $8,000,000. Regista: Ethan Coen.
Drive-Away Dolls: la recensione del film crime di Ethan Coen
09/09/2025 recensione film Drive-Away Dolls di Marco Tedesco
Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan sono al centro di una commedia sgangherata e rumorosa che tenta lo stile tipico dei due fratelli, ma resta un’imitazione svuotata di ritmo e sostanza

Drive-Away Dolls è un esperimento solitario di Ethan Coen che cerca di riaccendere la scintilla delle prime commedie crime dei fratelli Coen senza ritrovarne la doppia anima, quella frizzante e quella tragica, che ne teneva in equilibrio la stramberia. Quasi tutti rilevano lo stesso scarto: alla velocità dei lazzi non corrisponde un disegno comico preciso; la rumorosa voglia di eccesso non si traduce in vera comicità; l’ossatura del racconto si affida a un congegno usurato – la valigetta e l’inseguimento – che qui vale più come pretesto che come motore.
La scelta del 1999 dovrebbe dare identità al contesto e, insieme, giustificare l’assenza di telefonini che stroncherebbero sul nascere l’intreccio. Ma il periodo resta un fondale: pochi dettagli d’ambiente, qualche citazione musicale, nessuna riflessione sul passaggio d’epoca. In più di una lettura il ricorso alla cornice temporale appare un alibi narrativo, non una lente. Da qui l’impressione di un racconto “sospeso”: non dialoga con il presente e non illumina davvero quel passato prossimo.
Il registro comico, dichiaratamente sguaiato, punta a un’aria di farsa libertina e di film di serie B: nomi di locali spinti, intermezzi psichedelici, trovate grossolane sul corpo e sui giocattoli sessuali, una linea politica laterale che coinvolge un senatore dalla doppia morale. Sulla carta, la miscela potrebbe funzionare: erotismo sfrontato, corruzione pubblica, violenza a scatti, due amiche agli antipodi che scoprono di attrarsi durante un viaggio verso la Florida. Quasi tutti però notano il medesimo inciampo: la risata fatica ad arrivare perché il film confonde il volume con il ritmo, l’iperbole con il tempo comico. Le gag visive – passaggi di scena giocosi, caleidoscopi, trovate grafiche – cercano di coprire lo scarto fra ambizione e resa; finiscono invece per sottolinearlo.
Sul piano dei personaggi il giudizio converge ancora. Jamie, interpretata da Margaret Qualley, è disegnata come un vortice di desiderio, accento texano calcato e battute zuccherose a ripetizione: una maschera a cui si chiede di riempire ogni vuoto con rumorosa vitalità. Molti trovano questa energia forzata, più posa che carattere, più spinta esterna che scintilla interna. Al contrario Marian, cui dà corpo Geraldine Viswanathan, ha grazia trattenuta e ironia secca, ma il film la usa soprattutto in funzione di contrasto; resta spesso in ombra, come se l’idea stessa di “opposti che si attraggono” bastasse a garantire la dinamica senza bisogno di scavarne i motivi.
In un’opera che vorrebbe celebrare il desiderio femminile e lesbico, la rappresentazione oscilla tra intenzione liberatoria e stereotipo ammiccante: quando la sessualità diventa il perno di quasi ogni gag, il passo dalla liberazione all’oggettivazione è breve, e qui più volte varcato.
Gli attori di contorno, pur di alto profilo, faticano a lasciare traccia. Colman Domingo ha autorevolezza ma si dissolve dalla trama quando servirebbe rilancio; Pedro Pascal apre con un episodio sanguinoso che promette un’altra energia e resta isolato; Matt Damon compare e scompare in una breve apparizione che vorrebbe dare peso politico al segreto nella valigetta ma non regge a una minima verifica logica. All’opposto, Beanie Feldstein è come la presenza comica più compiuta: furia gelosa incontrollabile, ma sempre leggibile, capace di strappare le poche risate piene di un racconto che di risate vive e che qui non le trova. Bill Camp, con il suo impasto di malinconia e doppiezza, dà invece sostanza al traghettatore intermedio, la pedina sacrificabile che in molte storie dei Coen portava un lampo di pietà: anche questo lampo, però, rimane isolato.
 Ad ogni modo, la confezione è curata: fotografia di qualità, musiche di un collaboratore storico, scenografie che non lesinano dettagli. Eppure la forma non smentisce la sostanza: l’alto artigianato non genera necessità drammaturgica. Gli intermezzi lisergici, le dissolvenze giocattolo, le trovate grafico-musicali paiono un vezzo più che un linguaggio; lo stesso richiamo a modelli del passato – il cinema sensazionalistico, il noir che ruota intorno a un oggetto misterioso, persino il rimando a un romanzo di Henry James letto in scena – resta citazione, non reinvenzione.
Ad ogni modo, la confezione è curata: fotografia di qualità, musiche di un collaboratore storico, scenografie che non lesinano dettagli. Eppure la forma non smentisce la sostanza: l’alto artigianato non genera necessità drammaturgica. Gli intermezzi lisergici, le dissolvenze giocattolo, le trovate grafico-musicali paiono un vezzo più che un linguaggio; lo stesso richiamo a modelli del passato – il cinema sensazionalistico, il noir che ruota intorno a un oggetto misterioso, persino il rimando a un romanzo di Henry James letto in scena – resta citazione, non reinvenzione.
Il confronto implicito con la filmografia dei fratelli è inevitabile. Quando funzionavano al meglio, le loro storie tenevano insieme due qualità: l’attrazione per l’assurdo e un senso morale severo. L’assurdo nasceva da una logica ferrea portata all’estremo; la risata, persino la più sguaiata, si appoggiava a un montaggio preciso, a pause calcolate, a un’idea di destino che colpiva i personaggi quando meno se lo aspettavano ma secondo regole non arbitrarie. Qui, in assenza di quel contrappeso, la stramberia resta stramberia: i malviventi litigano senza minacciare, l’inseguimento non stringe, l’oscenità non ferisce, la politica non punge. Si avverte la mancanza di una mano che trattenga, asciughi, tolga, per far emergere la forma del comico sotto la polvere dell’iperbole.
Resta la questione della rappresentazione. Il film rivendica protagoniste lesbiche senza pudori e senza sensi di colpa: è un merito, e non piccolo, in un territorio – la commedia criminale – che storicamente ha parlato d’altro e ad altri. Ma la buona intenzione non basta: quando identità e desiderio divengono carburante per battute ripetute, la sorpresa iniziale si consuma presto; ciò che potrebbe essere gesto di liberazione si trasforma in traccia prevedibile. Potremmo considerarlo comunque un passo avanti sul piano simbolico, ma senza personaggi credibili la bandiera dell’inclusione sventola nel vuoto.
L’oggetto misterioso al centro dell’intreccio (il tipico MacGuffin), infine, dovrebbe concentrare l’attenzione, tenere insieme i fili, fornire una rivelazione all’altezza della suspense costruita. Non accade. L’epilogo vale come sberleffo più che come disvelamento; lascia dietro di sé l’eco di una risata breve e nulla più. Anche qui si coglie la differenza con i modelli evocati: quando l’oggetto era solo un espediente, attorno c’era un mondo morale compatto; qui non c’è né l’uno né l’altro.
Il risultato è un’opera breve che sembra lunga, movimentata e al tempo stesso immobile, piena di trovate e povera di necessità. La solitudine di Ethan Coen non è una colpa, è un dato. Ma Drive-Away Dolls mostra quanto, in quell’antica collaborazione, il freno fosse parte del motore. Dove mancava la gravità arrivava la caduta, dove l’arguzia scarseggiava interveniva il silenzio, dove l’assurdo rischiava la caricatura subentrava la pena. Qui, invece, domina l’allegria programmata: chiassosa, insistita, spesso compiaciuta. Il cinema dei Coen, quello grande, faceva ridere perché prima ancora capiva i suoi personaggi e le loro sventure; questo film, pur affollato di volti noti e di buone maestranze, sembra contentarsi di imitarne i tic. È la differenza tra un gesto e il suo calco: a prima vista coincidono, ma al tatto manca il calore.
Di seguito il trailer italiano di Drive-Away Dolls:
© Riproduzione riservata