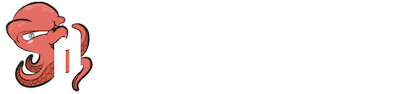Titolo originale: Magnificat , uscita: 09-04-1993. Regista: Pupi Avati.
Recensione story: Magnificat di Pupi Avati (1993)
09/03/2021 recensione film Magnificat di Marco Tedesco
Nel 1993 il regista tornava sulle scene con un dramma storico rigoroso e riflessivo, capace di alternare momenti di quiete e immagini crude

Reduce dal biopic Bix (1991), quasi certo in partenza che non avrebbe conquistato le cine-masse della Pasqua di quell’anno, Pupi Avati ha fatto comunque bene a girare Magnificat. Giunto all’età di 54 anni, dopo un infarto che l’aveva per un attimo condotto al cospetto della Nera Mietitrice, il regista bolognese si immergeva nel 1993 nel clima dell’alto Medioevo italiano con un film personale e ispirato, presentato in concorso al Festival di Cannes, nel quale condensava gli interrogativi religiosi che gli erano sempre stati cari.
Da buon propagandista di sé stesso, Pupi Avati riassumeva all’epoca in un bel concetto il senso dell’esperimento:
L’uomo moderno ha imparato a convivere con il silenzio di Dio, e può finalmente porre se stesso al centro del sistema. Al contrario, l’uomo medioevale cercava – e voleva – riconoscere Dio in tutto ciò che lo circondava.
Magnificat, sin dal titolo, si propone come lode alle ragioni di una fede, non necessariamente quella cattolica, dentro un’ambientazione storicamente attendibile: per questo sbaglierebbe chi lo vedesse come il capriccio di un ‘baciapile’, ancorché intellettuale. Nel realizzarlo in gelosa segretezza, Pupi Avati aveva applicato al suo cinema una passione storiografica coltivata negli anni, consultando libri su libri, contaminando suggestioni e fonti, nell’ottica di una verosimiglianza antropologica-poetica che si vuole rigorosa, a prova di esperto.
Ma certo non è necessario aver divorato Gregorio di Tours e Paolo Diacono, le lettere di Abelardo ed Eloisa e nemmeno i saggi di Le Goff e Bloch per apprezzare il tono sommesso, da microstoria, che Magnificat sfodera nel suo apparato corale.
 Il film intreccia varie storie nella cornice della Settimana santa del 926 dopo Cristo. In una zona indefinita della Pentapoli, tra le valli appenniniche già scaldate dal sole primaverile, una serie di personaggi confluiscono a Malfole, dove sorge il monastero e l’abbazia dell’Annunciazione.
Il film intreccia varie storie nella cornice della Settimana santa del 926 dopo Cristo. In una zona indefinita della Pentapoli, tra le valli appenniniche già scaldate dal sole primaverile, una serie di personaggi confluiscono a Malfole, dove sorge il monastero e l’abbazia dell’Annunciazione.
Con il suo seguito di serve e levatrici, la concubina reale Roza (Dalia Lahav), gravida di nove mesi, spera di poter donare un erede maschio al re che l’ha fecondata. Sta per morire invece, tormentato dalle pustole, il signore del luogo, Gomario Grifone (Luigi Diberti), il quale, dopo aver regolato le incombenze ereditarie e salutato la giovane amante, si chiude in una tenda in riva al fiume.
Al monastero, intanto, è appena giunta la novizia quattordicenne Margherita, donata dal padre mugnaio (Massimo Sarchielli) alla Chiesa e costretta al silenzio dalla disciplina monacale.
Parlano molto, invece, il boia Folco (Arnaldo Ninchi) e il nuovo assistente Baino (Massimo Bellinzoni): tra l’affogamento di un’adultera e lo squartamento di un uxoricida sottoposto al giudizio di Dio. il vecchio carnefice non sa rassegnarsi alla morte del figlio e chiede all’Aldilà segnali che non arrivano mai. E poi ci sono frate Agnello (Vincenzo Crocitti), che ogni anno fa il giro dei conventi e dei monasteri per annoiare le dipartite dei religiosi; : giovani diaconi che si sfidano giocosi a colpi di versetti; i due contadini che si sposano con la benedizione (quasi uno jus primae noctis) del nuovo signore di Malfole, a sua volta intento a interrogare la natura sul destino ultraterreno del padre appena morto.
Film di alto profilo, talvolta appesantito da una voce narrante (Nando Gazzolo) che indugia in citazioni d’epoca, Magnificat ha il pregio di non sfiorare mai il ridicolo. Rigettando qualsiasi tentazione brancaleonesca e anzi opponendo al grottesco poveristico una fisiognomica plausibile, Pupi Avati intona un Te Deum che, in questi tempi di neo-spiritualismo, potrebbe essere apprezzato anche dai laici (ai quali, per singolare coincidenza, si rivolgeva nel 1992 pure il Memé Perlini ‘apocrifo’ del Ventre di Maria).
Più che la ritualità liturgica di certi passaggi al lume di candela o la combinazione di echi barbarici e fissità bizantine, colpisce il senso di quieta riflessione sulla morte che traspare dai gesti e dalle parole di questi personaggi, siano nobili o servi, cui il regista sembra affidare parti di sé, vacillando insieme ad essi quando non arrivano dal cielo i segnali sperati.
Se un film corale va giudicato nel suo insieme, bisogna però riconoscere a Magnificat che l’episodio del boia si staglia sugli altri per l’equilibrio tra umana pietà e atroce crudeltà, rivelando il talento di un attore maturo, sensibile, ingiustamente sottovalutato dal cinema, come Arnaldo Ninchi. Mentre sul piano poetico-visivo si impone l’idea di quell’uccellino di legno, piazzato in cima alla pertica piantata nel cimitero, che la novizia scolpisce con le proprie mani: murata viva nel monastero, non le resta, per comunicare con la famiglia al di là dei monti, che quell’antica usanza pagana.
Di seguito il trailer di Magnificat:
© Riproduzione riservata