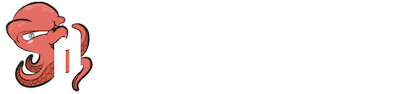Cineocchio Dossier – Wuxiapian: sguardo su un genere intangibile (Parte III)
03/02/2016 news di Michele Senesi
Siamo arrivati agli anni '90: tra incertezze per il futuro e crisi dell'industria, fa capolino l'interesse di Hollywood

Hong Kong, siamo a casa
Le novità citate porteranno ai grandi decenni di gloria dei coreografi marziali. Nonostante il numero tutto sommato elevato di nomi degni di nota (a cui si affiancano eccellenti direttori di scontri e inseguimenti automobilistici e responsabili di ogni possibilità di messa in scena dell’azione), due saranno principalmente le scuole di pensiero che nel wuxiapian avranno maggiore risalto. La prima è quella incarnata da Ching Siu-tung, la seconda quella di Yuen Woo-ping.
 Il primo fa della frammentazione, del dettaglio, della furia e della frenesia di stimoli rimasticati da un montaggio impazzito il segreto delle sue coreografie incredibili, economiche e sorprendenti. Il secondo è invece maestro nella fluidità dei movimenti, della pulizia dei raccordi, della limpidezza percettiva delle dinamiche e della fusione cristallina tra movimento di macchina, dell’attore e del mélange con la partitura sonora. Sono gli anni del wirework (sistema di imbracatura e cavi per far volare gli spadaccini), dei trampolini, del fumo sintetico e delle luci secche e colorate, degli effetti ottici e di infiniti artifizi per ritrovare la visione fantastica e poco verosimile del senso del meraviglioso dell’origine letteraria.
Il primo fa della frammentazione, del dettaglio, della furia e della frenesia di stimoli rimasticati da un montaggio impazzito il segreto delle sue coreografie incredibili, economiche e sorprendenti. Il secondo è invece maestro nella fluidità dei movimenti, della pulizia dei raccordi, della limpidezza percettiva delle dinamiche e della fusione cristallina tra movimento di macchina, dell’attore e del mélange con la partitura sonora. Sono gli anni del wirework (sistema di imbracatura e cavi per far volare gli spadaccini), dei trampolini, del fumo sintetico e delle luci secche e colorate, degli effetti ottici e di infiniti artifizi per ritrovare la visione fantastica e poco verosimile del senso del meraviglioso dell’origine letteraria.
A metà anni ’90 in pieno boom del genere si stava ripetendo quello che era avvenuto 20 anni prima; sovrapproduzione, plagi, titoli derivativi, tendenza al risparmio e lenta discesa verso la maniera. Ma ecco che iniziano ad arrivare i segnali del fatto che qualcosa stava per cambiare; il primo è Wong Kar-wai (Hong Kong Express, In the Mood for Love) con il suo Ashes of Time, sorta di canto del cigno e visione crepuscolare del genere. Un altro segno arriva dalle coreografie brutali dell’esordio alla regia di Donnie Yen (Ip Man) intitolato Legend of the Wolf. E un altro esordio, proprio come ai tempi della new wave di inizi ’80 è quello di Daniel Lee con il suo brutale e raffinato What Price Survival del 1994, non troppo casualmente lo stesso anno di Ashes of Time.
 Ma di nuovo è Tsui Hark a porre la pietra tombale del wuxiapian. Il regista ha sempre evitato la maniera e il successo facile e ha tentato sempre una strada in cui la novità, l’invenzione e l’originalità fossero le basi da cui far sbocciare i generi e decine -se non centinaia- di prodotti derivati. Come aveva rigenerato il filone lo uccide con il suo The Blade del 1995, punto di non ritorno estremo e oscuro del genere. Cancella tutto quello che aveva creato, elimina i cavi, riporta la violenza a terra e la rende palpabile e priva di eroismi, sprofonda la narrazione in un indecifrabile e verosimile medioevo popolato di bande di predoni tatuati ed elegge una nuova filosofia della spada. E’ l’unico a raggiungere i livelli stilistici del The Valiant Ones di King Hu già citato e crea un precedente, senza una goccia di effetti digitali che ad oggi, altri 20 anni dopo, non ha avuto eguali.
Ma di nuovo è Tsui Hark a porre la pietra tombale del wuxiapian. Il regista ha sempre evitato la maniera e il successo facile e ha tentato sempre una strada in cui la novità, l’invenzione e l’originalità fossero le basi da cui far sbocciare i generi e decine -se non centinaia- di prodotti derivati. Come aveva rigenerato il filone lo uccide con il suo The Blade del 1995, punto di non ritorno estremo e oscuro del genere. Cancella tutto quello che aveva creato, elimina i cavi, riporta la violenza a terra e la rende palpabile e priva di eroismi, sprofonda la narrazione in un indecifrabile e verosimile medioevo popolato di bande di predoni tatuati ed elegge una nuova filosofia della spada. E’ l’unico a raggiungere i livelli stilistici del The Valiant Ones di King Hu già citato e crea un precedente, senza una goccia di effetti digitali che ad oggi, altri 20 anni dopo, non ha avuto eguali.
 A tutti i segni nefasti citati si aggiunge l’altro grande trauma di Hong Kong, ovvero l’incertezza di cosa sarebbe avvenuto una volta tornata alla Cina nel 1997, terminato quindi il periodo coloniale inglese. Gli investimenti calano, il cinema più cupo viene eliminato dalle sale e i maggiori talenti “scappano” a Hollywood (Chow Yun-fat, Jet Li, Jackie Chan, Ringo Lam, Kirk Wong, Corey Yuen, lo stesso Tsui Hark…).
A tutti i segni nefasti citati si aggiunge l’altro grande trauma di Hong Kong, ovvero l’incertezza di cosa sarebbe avvenuto una volta tornata alla Cina nel 1997, terminato quindi il periodo coloniale inglese. Gli investimenti calano, il cinema più cupo viene eliminato dalle sale e i maggiori talenti “scappano” a Hollywood (Chow Yun-fat, Jet Li, Jackie Chan, Ringo Lam, Kirk Wong, Corey Yuen, lo stesso Tsui Hark…).
Altri o vanno in un ritiro forzato o restano a “combattere” tenacemente in patria variando i generi e gli stili, come Johnnie To che inizia la sua strada nel noir a basso budget. Se a tutto questo sommiamo il periodo di crisi dovuto alla SARS, si è di fronte al canto del cigno di un cinema e di un paese.
Ma come abbiamo visto, la popolazione di Hong Kong non è abituata a scoraggiarsi e a darsi per vinta. Innanzi tutto un evento buffo da notare è che mentre il metodo di messa in scena di certe dinamiche è ormai morto in patria e la produzione del genere sta calando drasticamente, questo viene “scoperto” negli USA, adottato e proposto come la grande novità del cinema locale. Il film d’azione pesante, muscolare e balistico degli anni ’80 lascia spazio a un’azione più dinamica e lieve.
I Tre Moschettieri (1993) di Stephen Herek che plagia il duello con le scale di Once Upon a Time in China (1991) di Tsui Hark, La Maschera di Zorro (1999) di Martin Campbell che rubacchia da New Dragon Gate Inn (1992) di Raymond Lee, fino ad arrivare al boom di Matrix vero agglomerato, seppur originale e rigoroso, di tantissime influenze della cultura pop cinese e giapponese e Kill Bill, accozzaglia -tra l’altro- di infinite scene, personaggi, musiche, situazioni provenienti proprio dal kung fu movie classico dei ’70.
 E’ in questa atmosfera che vede la luce La Tigre e il Dragone, capostipite non di un genere ma di una più elaborata e consapevole esigenza di marketing per rilanciare lo stesso e soprattutto renderlo appetibile ad un pubblico occidentale. Produzioni cinesi a cui si affianca spesso l’iniezione di fondi americani, profluvio di elementi esotici e riconoscibili da uno spettatore generico ma, soprattutto, il non prestare più la regia a nomi di genere o coreografi, ma a autori da Festival lontanissimi in sensibilità dal wuxiapian. Passano sotto questa gogna in ordine sparso Ang Lee (La Tigre e il Dragone), Zhang Yimou (Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti, La Città Proibita), Feng Xiaogang (The Banquet), Chen Kaige (The Promise); film patinati, ad alto budget, coloratissimi, colmi di effetti digitali e di un profluvio di utilizzo dei cavi, estetizzanti, contemplativi, fasciati da una accecante confezione deluxe.
E’ in questa atmosfera che vede la luce La Tigre e il Dragone, capostipite non di un genere ma di una più elaborata e consapevole esigenza di marketing per rilanciare lo stesso e soprattutto renderlo appetibile ad un pubblico occidentale. Produzioni cinesi a cui si affianca spesso l’iniezione di fondi americani, profluvio di elementi esotici e riconoscibili da uno spettatore generico ma, soprattutto, il non prestare più la regia a nomi di genere o coreografi, ma a autori da Festival lontanissimi in sensibilità dal wuxiapian. Passano sotto questa gogna in ordine sparso Ang Lee (La Tigre e il Dragone), Zhang Yimou (Hero, La Foresta dei Pugnali Volanti, La Città Proibita), Feng Xiaogang (The Banquet), Chen Kaige (The Promise); film patinati, ad alto budget, coloratissimi, colmi di effetti digitali e di un profluvio di utilizzo dei cavi, estetizzanti, contemplativi, fasciati da una accecante confezione deluxe.
continua…
© Riproduzione riservata