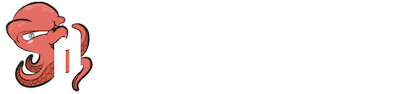Voto: 6.5/10 Titolo originale: The Sandman , uscita: 05-08-2022. Stagioni: 3.
The Sandman, stagione 2: la recensione dei 5 episodi del Volume 2
24/07/2025 recensione serie tv The Sandman di Marco Tedesco
Un finale tra mito, morte e trasformazione. Un epilogo poetico per il Signore dei Sogni

Con la seconda parte della stagione 2, The Sandman si congeda definitivamente dal pubblico, concludendo un viaggio lungo, stratificato e ambizioso che ha saputo fondere mitologia, letteratura e introspezione. La serie Netflix, ispirata all’opera monumentale di Neil Gaiman, sceglie di chiudere con 5 episodi intensi, profondamente meditativi e intrisi di una malinconia consapevole.
In un panorama televisivo dominato da finali affrettati o artificiosamente spettacolari, The Sandman osa un congedo coerente, doloroso, poetico. Il risultato è un’esperienza che, pur soffrendo di alcune limitazioni strutturali e produttive, si eleva per profondità tematica, forza simbolica e raffinatezza narrativa.
Morfeo, o Sogno, il Signore dell’Infinito, è finalmente costretto a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. Il gesto compassionevole ma proibito di porre fine alla sofferenza del figlio Orfeo gli attira la condanna delle Furie. Il tema della colpa, del destino e dell’autodistruzione si intreccia così con quello dell’evoluzione: The Sandman non racconta solo la caduta di un dio, ma la lenta e dolorosa nascita di un’umanità nuova. La narrazione si stringe intorno alla figura di Sogno, non più distante osservatore ma entità stanca, spezzata, che finalmente comprende che l’eternità non è una benedizione ma una condanna, se priva di legami e mutamento.
Tom Sturridge, sempre misurato, offre qui la sua interpretazione più intensa e sfaccettata. Non alza mai la voce, non cerca la scena: incarna un personaggio che parla attraverso lo sguardo, le pause, i silenzi. Morfeo si spezza un poco in ogni episodio, e lo spettatore avverte questa frattura crescere, fino alla catarsi finale. Lontano dagli standard recitativi più urlati e teatrali, Sturridge afferma che anche la fragilità ha diritto di esistere nel regno degli dèi.
Attorno a lui, ruotano figure che danno corpo al caos, al desiderio, alla speranza. Loki e Puck, interpretati con diabolica ambiguità da Freddie Fox e Jack Gleeson, incarnano un disordine seducente e distruttivo. La loro relazione è carica di tensione erotica e manipolazione reciproca, un gioco perverso che alimenta la trama e amplifica il senso di precarietà. Jenna Coleman ritorna come Johanna Constantine, e la sua dinamica con il Corinzio – un Boyd Holbrook rinnovato, meno mostruoso e più complesso – introduce un’insperata umanità nel cuore dell’oscurità. La loro complicità, costruita su cinismo, ironia e solitudini affini, è uno dei fili più preziosi di questa conclusione.
 Se la prima stagione e la prima parte della seconda esploravano il mito attraverso una struttura quasi episodica, questi ultimi episodi si stringono in una narrazione più compatta, focalizzata e tragica. Ma non mancano le divagazioni emotive: l’incontro con i genitori Tempo e Notte, il confronto con i fratelli Eterni, gli addii silenziosi ai compagni del Sogno. Ogni scena respira un’urgenza nuova, perché il tempo – paradosso per un essere immortale – ora scorre. Anche i personaggi minori, da Nuala a Lucienne, da Hob Gadling a Delirio, contribuiscono a definire il paesaggio affettivo e mitologico in cui Sogno si muove. La famiglia degli Eterni, finalmente al completo, diventa specchio di tutte le famiglie: legami spezzati, ferite mai rimarginate, ma anche un barlume di redenzione.
Se la prima stagione e la prima parte della seconda esploravano il mito attraverso una struttura quasi episodica, questi ultimi episodi si stringono in una narrazione più compatta, focalizzata e tragica. Ma non mancano le divagazioni emotive: l’incontro con i genitori Tempo e Notte, il confronto con i fratelli Eterni, gli addii silenziosi ai compagni del Sogno. Ogni scena respira un’urgenza nuova, perché il tempo – paradosso per un essere immortale – ora scorre. Anche i personaggi minori, da Nuala a Lucienne, da Hob Gadling a Delirio, contribuiscono a definire il paesaggio affettivo e mitologico in cui Sogno si muove. La famiglia degli Eterni, finalmente al completo, diventa specchio di tutte le famiglie: legami spezzati, ferite mai rimarginate, ma anche un barlume di redenzione.
Dal punto di vista visivo, la serie continua a offrire immagini suggestive, anche se l’immaginario dei fumetti risulta talvolta sacrificato. I limiti di budget e la complessità dell’universo visivo di Gaiman hanno imposto scelte minimaliste, e se alcune sequenze restano memorabili, altre non rendono giustizia alla vastità del materiale originale. Tuttavia, la fotografia, il design sonoro e la musica riescono spesso a colmare queste lacune, costruendo un’atmosfera rarefatta, sospesa tra sogno e incubo.
Dal punto di vista dell’adattamento, la compressione dei volumi Le Eumenidi e La Veglia in pochi episodi è un’impresa ardua, forse impossibile. Alcune sottotrame sono eliminate, altre semplificate. Ma la sceneggiatura fa scelte intelligenti, privilegia il cuore tematico rispetto all’esaustività. Non si tratta di raccontare tutto, ma di chiudere bene. E, sorprendentemente, riesce a farlo. Il messaggio non è forzato: emerge con naturalezza. La morte non è una sconfitta, ma un passaggio. L’evoluzione non è una perdita di identità, ma una conquista. Le storie non sono eterne perché infinite, ma perché sanno quando finire.
La serie affronta anche, con sottile metanarrazione, la condizione dell’arte contemporanea. In un tempo in cui ogni prodotto viene rilanciato, riavviato, spremuto, The Sandman afferma il valore della conclusione. La sua fine non è debolezza ma dignità. È un’opera che, consapevole di dover chiudere per motivi esterni, decide di farlo senza svendersi. Resta fedele a sé stessa, anche nel commiato.
Ciò che The Sandman lascia è molto più di una bella serie fantasy. È una meditazione sul tempo, sull’identità, sulla memoria. Un’opera che guarda al mito per parlare all’oggi, che usa dèi ed eterni per raccontare le paure e i desideri umani. È il racconto di un dio che impara a morire per comprendere cosa significhi vivere. È un sogno che svanisce, ma che lascia traccia. E forse è proprio questo il suo miracolo più grande: insegnarci che i sogni valgono non perché durano per sempre, ma perché, quando finiscono, ci cambiano.
Di seguito trovate la scena di apertura del Volume 2 della stagione 2 di The Sandman, su Netflix dal 24 luglio:
© Riproduzione riservata