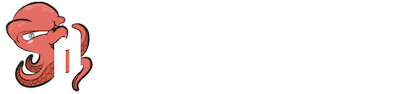Voto: 7/10 Titolo originale: Bugonia , uscita: 23-10-2025. Budget: $50,000,000. Regista: Yorgos Lanthimos.
Bugonia: la recensione del film di Yorgos Lanthimos
31/08/2025 recensione film Bugonia di William Maga
Il remake di Save the Green Planet! è una commedia nera che interroga potere, complotti e responsabilità

Bugonia è il ritorno di Yorgos Lanthimos ai territori più spigolosi del suo cinema dopo il successo presso il grande pubblico di La favorita e Povere creature!. Il punto di partenza è semplice e tagliente: Teddy (Jesse Plemons), apicoltore ossessionato dal collasso delle api e dalle cospirazioni, rapisce con l’aiuto del cugino Don (Aidan Delbis) Michelle Fuller (Emma Stone), amministratrice di una potente azienda biofarmaceutica. È convinto che lei sia un’aliena di Andromeda e che l’umanità possa salvarsi solo prima della prossima eclissi.
Da questa premessa, che potrebbe scivolare nella caricatura, Lanthimos costruisce una commedia nera claustrofobica e controllatissima, dove la risata è un coltello e l’empatia una trappola morale.
Il film nasce come rifacimento di “Save the Green Planet!” (2003) di Jang Joon-hwan, e proprio questo legame ne condiziona la lettura: non si limita a trasporre, ma interroga l’atto stesso di “rifare”. La fedeltà al congegno originale convive con uno scarto d’autore: l’ossessione di Teddy non è soltanto un sintomo, è un metodo. Il sequestro diventa laboratorio etico, stanza delle torture ma anche aula di psicologia collettiva.
In questa camera di decompressione Lanthimos riattiva la sua doppia natura: l’entomologo che osserva gli umani come insetti, e il moralista che chiede conto di ogni autoassoluzione. La domanda che attraversa il film non è “Michelle è un’aliena?”, bensì “quale forma di disumanità accettiamo ogni giorno pur di non guardarla in faccia?”.
La tessitura tematica è fitta. C’è la voglia di trovare un capro espiatorio quando il mondo vacilla; c’è il rancore sociale che cerca un linguaggio e sceglie il più facile, quello del complotto; c’è l’industria che parla di cura mentre produce scarti umani e linguistici; c’è soprattutto la necessità di credere a qualcosa, qualunque cosa, per non sentirsi irrilevanti. Teddy confessa di aver attraversato ideologie opposte senza trovare riparo: le ha indossate come maschere, finché l’ipotesi extraterrestre non gli ha offerto l’ordine perfetto. Michelle, dal canto suo, incarna l’ipocrisia ben educata del potere: frasi di circostanza, welfare aziendale di facciata, attenzione alla forma che sterilizza il conflitto. Nello scontro fra i due, il film misura la distanza fra verità e utilità, fra fede privata e responsabilità pubblica.
 Lanthimos tiene insieme farsa e tragedia con una precisione che ricorda Il sacrificio del cervo sacro, ma con un’ironia più terrena. La narrazione segue un conto alla rovescia in tre atti, marcato da cartelli che comprimono il tempo e dilatano l’ansia: ogni giorno si avvicina al punto di non ritorno, ogni interrogatorio riallinea le nostre simpatie. La regia alterna sadismo e pietà senza mai indicare una via giusta; il film è arrabbiato, ma non militante, e proprio per questo più scomodo. Quando la violenza esplode, non è catarsi: è l’ennesimo tentativo di imporre un senso a un caos che non ne ha.
Lanthimos tiene insieme farsa e tragedia con una precisione che ricorda Il sacrificio del cervo sacro, ma con un’ironia più terrena. La narrazione segue un conto alla rovescia in tre atti, marcato da cartelli che comprimono il tempo e dilatano l’ansia: ogni giorno si avvicina al punto di non ritorno, ogni interrogatorio riallinea le nostre simpatie. La regia alterna sadismo e pietà senza mai indicare una via giusta; il film è arrabbiato, ma non militante, e proprio per questo più scomodo. Quando la violenza esplode, non è catarsi: è l’ennesimo tentativo di imporre un senso a un caos che non ne ha.
Sul piano visivo, la scelta del “piccolo formato” è ingannevole. L’ambientazione è ristretta, eppure il respiro è da opera maggiore. La fotografia oppone la tana di Teddy – legni, muffa, verdi e ocra saturi, il disordine come paesaggio mentale – alla casa di vetro di Michelle, una navicella borghese atterrata nella provincia. Nelle scene di interrogatorio, la macchina da presa adotta angoli opposti per i due volti: basso per lui, alto per lei. È un ribaltamento sottile che rovescia i ruoli di carnefice e martire, fino a confonderli. L’illuminazione scava i lineamenti con una durezza espressionista, mentre il montaggio lascia respirare gli scarti comici prima di serrarsi nei momenti di crudeltà. La musica, capace di passare dal minimalismo al clangore orchestrale, non accompagna: infierisce, ride, smentisce.
Gli interpreti sono decisivi. Plemons offre una variazione spaventata e feroce del “devoto” lanthimosiano: corpo asciugato, voce che frana, lampi di tenerezza che rendono più sinistre le derive. La Stone costruisce una dirigente che parla il lessico dell’autogiustificazione: il suo sguardo, via via privato di ogni schermo, passa dall’arroganza al calcolo di sopravvivenza senza perdere lucidità. Delbis, come Don, porta l’unico respiro di innocenza, e proprio per questo è la figura più tragica: è l’anello debole che regge l’intera catena del ricatto emotivo. Le figure esterne – la madre di Teddy, il tutore dell’ordine – servono da specchi deformanti: ogni volta che il mondo entra in cantina, il film mostra quanto sia già in rovina prima ancora di varcare la porta.
Bugonia è anche un racconto sul linguaggio. Michelle parla la neolingua della cura aziendale; Teddy parla il catechismo del sospetto; Don balbetta desideri di normalità. Nessuno ascolta davvero. Il rapimento costringe i tre a un duello di definizioni, corpi, prove, e ogni parola diventa un’arma spuntata. In questo clima di incomprensione sistematica, l’apicoltura assume valore simbolico: l’alveare come società ideale in cui ogni individuo conosce il proprio compito, minacciata da un collasso che nessuno riesce più a nominare senza mentire.
 Il titolo rimanda al mito antico delle api nate dalle carcasse: dalla putrefazione come possibile origine di una nuova vita. Ma qui la rinascita non è promessa: è un’ipotesi che richiede l’amputazione delle “compulsioni psichiche” di cui i personaggi parlano, cioè l’egoismo che devasta ogni comunità.
Il titolo rimanda al mito antico delle api nate dalle carcasse: dalla putrefazione come possibile origine di una nuova vita. Ma qui la rinascita non è promessa: è un’ipotesi che richiede l’amputazione delle “compulsioni psichiche” di cui i personaggi parlano, cioè l’egoismo che devasta ogni comunità.
Se il film ha un limite, è nella sua insistenza: a tratti l’argomentazione si allunga oltre il necessario e la ripetizione mira più a stordire che a convincere. Un’ora e mezza gli avrebbe garantito una compattezza quasi perfetta. E tuttavia quella ridondanza è coerente con il tema della coazione a ripetere: il mondo che Bugonia mette in scena è bloccato in un circuito di autoinganno e punizione, e il pubblico è chiamato a condividere la fatica. Il finale, più che una risposta, è un verdetto sulle nostre abitudini morali: siamo bravissimi a chiedere salvezza, pessimi a cambiare.
Nel percorso di Lanthimos, Bugonia si colloca così fra la crudeltà geometrica de Il sacrificio del cervo sacro e l’energia vitalistica di Povere creature!, con l’innesto di una satira sociale che non assolve nessuno, né i crociati contro il capitale né chi il capitale lo gestisce col sorriso.
È un film che si diverte a farci inciampare e che, per una volta, non cerca alleati: chiede allo spettatore di scegliere se credere al racconto più comodo o accettare l’idea più sgradevole, quella che non c’è un “loro” da smascherare, ma un “noi” da disinnescare. Forse l’alveare può ancora essere salvato; più probabilmente, continueremo a raccontarci che c’è tempo.
Bugonia resta addosso proprio perché, dietro la ferocia, riconosce la nostra stanchezza e la nostra fame di assoluzioni. Non concede né l’una né le altre. E nella sua cantina, dove ogni risata graffia, mette a nudo la verità più semplice: il mostro non viene da fuori.
Se cercate una spiegazione del finale o un approfondimento sul significato del film, vi agevoliamo il nostro approfondimento.
Di seguito trovare il full trailer doppiato in italiano di Bugonia, nei nostri cinema il 23 ottobre:
© Riproduzione riservata