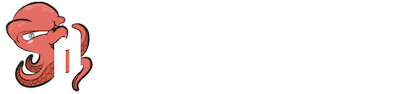Dossier – L’altro cinema belga (INTEGRALE)
18/03/2016 news di Nicola Altieri
Dalle Fiandre emerge un cinema che rivendica con sempre più fierezza la propria identità, ben distinta dalla tradizione francofona e dotata di una propria specificità rispetto alla vicina Olanda. Inizia un viaggio attraverso l'altro cinema belga.

Ma il Belgio esiste ancora?
 Il Belgio è uno stato federale composto da tre regioni. Una di queste è la Vallonia, popolata da circa 3 milioni e mezzo di abitanti di lingua francese, pari a poco più del 30% della popolazione totale. Al suo interno vi è una piccola comunità di lingua tedesca, composta da una manciata di comuni che tra prima e seconda guerra mondiale sono stati dapprima ceduti, poi annessi ed infine nuovamente ceduti dalla Germania al Belgio. C’è poi la piccola regione di Bruxelles, al cui interno vi è l’omonima capitale del paese. Nonostante si estenda per soli 160 km² è popolata da quasi 1 milione e mezzo di abitanti, circa il 10% della popolazione totale, è ufficialmente bilingue ma nei fatti il 90% è francofono. La minuscola regione di Bruxelles è situata nel bel mezzo della più popolosa delle tre regioni del Belgio, poco meno di 6 milioni e mezzo di abitanti, pari a circa il 60% della popolazione totale, è ufficialmente di lingua olandese ma nella realtà trattasi di una sua variante che possiede diverse specificità sul piano lessicale ed è detta, piuttosto impropriamente, fiammingo. Questa è la regione delle Fiandre.
Il Belgio è uno stato federale composto da tre regioni. Una di queste è la Vallonia, popolata da circa 3 milioni e mezzo di abitanti di lingua francese, pari a poco più del 30% della popolazione totale. Al suo interno vi è una piccola comunità di lingua tedesca, composta da una manciata di comuni che tra prima e seconda guerra mondiale sono stati dapprima ceduti, poi annessi ed infine nuovamente ceduti dalla Germania al Belgio. C’è poi la piccola regione di Bruxelles, al cui interno vi è l’omonima capitale del paese. Nonostante si estenda per soli 160 km² è popolata da quasi 1 milione e mezzo di abitanti, circa il 10% della popolazione totale, è ufficialmente bilingue ma nei fatti il 90% è francofono. La minuscola regione di Bruxelles è situata nel bel mezzo della più popolosa delle tre regioni del Belgio, poco meno di 6 milioni e mezzo di abitanti, pari a circa il 60% della popolazione totale, è ufficialmente di lingua olandese ma nella realtà trattasi di una sua variante che possiede diverse specificità sul piano lessicale ed è detta, piuttosto impropriamente, fiammingo. Questa è la regione delle Fiandre.
Al di là del provocatorio titolo, questo noioso preambolo geografico è un punto di partenza necessario per inquadrare la frammentata realtà belga e quanto complesso e spesso difficile sia il rapporto tra le diverse entità linguistiche. Quel che questi freddi numeri non dicono è che nei fatti molti fiamminghi sanno parlare il francese, pur avendo generalmente poca voglia di farlo, mentre pochi valloni sanno parlare il fiammingo ed hanno ben poca voglia di impararlo. Problemi linguistici ma soprattutto relazionali che si riflettono negativamente tanto nel commercio quanto nella vita di tutti i giorni.
L’altro cinema belga
 Diversità, specificità e difficoltà che lette ed elaborate hanno portato negli anni a costituire quella che caratterialmente, persino più che produttivamente e linguisticamente, è divenuta una cinematografia fiera e identitaria, in espansione e crescita costante, amata dalla sua gente che assalta le sale per vedere i propri film, con percentuali di fruizioni del prodotto interno in linea con l’eccellenza europea, ed è per questo che qui proveremo a tracciare un percorso parziale attraverso il cinema fiammingo contemporaneo, senza alcuna pretesa di completismo ma con l’intento di creare spunti d’approfondimento su autori, singole opere e peculiarità de “L’altro cinema belga”.
Diversità, specificità e difficoltà che lette ed elaborate hanno portato negli anni a costituire quella che caratterialmente, persino più che produttivamente e linguisticamente, è divenuta una cinematografia fiera e identitaria, in espansione e crescita costante, amata dalla sua gente che assalta le sale per vedere i propri film, con percentuali di fruizioni del prodotto interno in linea con l’eccellenza europea, ed è per questo che qui proveremo a tracciare un percorso parziale attraverso il cinema fiammingo contemporaneo, senza alcuna pretesa di completismo ma con l’intento di creare spunti d’approfondimento su autori, singole opere e peculiarità de “L’altro cinema belga”.
Nerbo e vitalità attraversano stili tra il folle e il bizzarro
 Un episodio è utile a descrivere il misto di bizzarria e follia che è tratto distintivo di molto del miglior cinema fiammingo. Festival Di Cannes del 2009, il giovane regista Felix Van Groeningen presenta il suo “De Helaasheid der dingen” (The Misfortunates, 2009) e per farlo insieme al suo cast sfila in bicicletta lungo le strade della città, lo fanno però pedalando completamente nudi e con gioiosi sorrisi stampati in faccia. Sorrisi che veicolano un film fatto di sbronze colossali, puzza d’alcol appiccicato sulla pelle e piscio sedimentato sui muri, un sudiciume di vite a pancia all’aria e culo nudo, una commedia greve e scurrile, spassosa nel suo spingere all’estremo ma cruda e drammatica nel delineare destini disperati, senza compiacimenti e intellettualismi, solo uno sguardo allucinato ma sincero, mai accondiscendente. Felix Van Groeningen, che due anni prima con il generazionale “Dagen Zonder Lief” (With Friends Like This, 2007) raccontava sei trentenni in equilibrio instabile tra spensieratezza e presa di coscienza della sopraggiunta maturità, ragazzi per cui ogni idea è un sogno, ogni sera un’avventura, ogni amico un fratello, poi arriva la vita, ti prende a cazzotti e niente è più come prima.
Un episodio è utile a descrivere il misto di bizzarria e follia che è tratto distintivo di molto del miglior cinema fiammingo. Festival Di Cannes del 2009, il giovane regista Felix Van Groeningen presenta il suo “De Helaasheid der dingen” (The Misfortunates, 2009) e per farlo insieme al suo cast sfila in bicicletta lungo le strade della città, lo fanno però pedalando completamente nudi e con gioiosi sorrisi stampati in faccia. Sorrisi che veicolano un film fatto di sbronze colossali, puzza d’alcol appiccicato sulla pelle e piscio sedimentato sui muri, un sudiciume di vite a pancia all’aria e culo nudo, una commedia greve e scurrile, spassosa nel suo spingere all’estremo ma cruda e drammatica nel delineare destini disperati, senza compiacimenti e intellettualismi, solo uno sguardo allucinato ma sincero, mai accondiscendente. Felix Van Groeningen, che due anni prima con il generazionale “Dagen Zonder Lief” (With Friends Like This, 2007) raccontava sei trentenni in equilibrio instabile tra spensieratezza e presa di coscienza della sopraggiunta maturità, ragazzi per cui ogni idea è un sogno, ogni sera un’avventura, ogni amico un fratello, poi arriva la vita, ti prende a cazzotti e niente è più come prima.
Un registro completamente diverso da quel “The Broken Circle Breakdown” (Alabama Monroe – Una storia d’amore, 2013) assurto a notorietà internazionale e candidato all’Oscar. Un ritratto doloroso e spietato, sapientemente contrappuntato da note di musica folk americana, in cui sogni e desideri naufragano in una vita che appare senza speranza alcuna, in cui aggrapparsi alla tristezza assoluta è l’unico modo per rimanere a galla. Tutt’altra musica ma sempre protagonista aggiunta nel corale “Any Way the Wind Blows” (2003) di quel Tom Barman già cantante e chitarrista degli storici dEUS.
 Un bel po’ di gente, assai disinvolta, per le strade di Anversa con nulla da fare o pretendere se non andare ad un party di qualcuno che non conoscono. Va dove ti porta il vento ma con un gran ritmo, con l’alternarsi delle storie che avviene come il cambio di traccia di un dj ed una folata di vento gradevole. Una musicalità e un andamento sinuoso che lo rendono un film adorabile, pur senza dire o fare granché. Rock urlato e sputato in faccia allo spettatore è invece quello di “Ex Drummer” (2007) di Koen Mortier, film dall’attitudine punk tanto nell’estetica e lo stile quanto nella vicenda raccontata. Una band di disadattati e deviati le cui gesta vengono filtrate da un occhio allucinato come il miglior Gaspar Noé e virtuosistico come il Danny Boyle degli esordi. Di tutt’altro genere il successivo “22 mei” (22nd of May, 2010), un quadro polveroso e funereo sulla morte ed il dramma della sopravvivenza in una vita di routine. Un viaggio surreale e onirico disegna il senso di colpa di un paese partendo dal singolo, attraverso una narrazione circolare e dilatata. D’ambientazione diversa ma di simili atmosfere oniriche è il più compiuto e ispirato “La Cinquième Saison” (La quinta stagione, 2012) dei coniugi Peter Brosens e Jessica Woodworth.
Un bel po’ di gente, assai disinvolta, per le strade di Anversa con nulla da fare o pretendere se non andare ad un party di qualcuno che non conoscono. Va dove ti porta il vento ma con un gran ritmo, con l’alternarsi delle storie che avviene come il cambio di traccia di un dj ed una folata di vento gradevole. Una musicalità e un andamento sinuoso che lo rendono un film adorabile, pur senza dire o fare granché. Rock urlato e sputato in faccia allo spettatore è invece quello di “Ex Drummer” (2007) di Koen Mortier, film dall’attitudine punk tanto nell’estetica e lo stile quanto nella vicenda raccontata. Una band di disadattati e deviati le cui gesta vengono filtrate da un occhio allucinato come il miglior Gaspar Noé e virtuosistico come il Danny Boyle degli esordi. Di tutt’altro genere il successivo “22 mei” (22nd of May, 2010), un quadro polveroso e funereo sulla morte ed il dramma della sopravvivenza in una vita di routine. Un viaggio surreale e onirico disegna il senso di colpa di un paese partendo dal singolo, attraverso una narrazione circolare e dilatata. D’ambientazione diversa ma di simili atmosfere oniriche è il più compiuto e ispirato “La Cinquième Saison” (La quinta stagione, 2012) dei coniugi Peter Brosens e Jessica Woodworth.
 Un progressivo disfacimento, ambientale e umano, di un mondo rurale bloccato nel suo inverno ma destinato a sopravvivere in un perenne e grigiastro autunno, un grigio sporcato di fango, sangue e sterco. Una lunga e allegorica messa funebre, capitolo conclusivo d’una trilogia sul rapporto uomo\natura di cui fanno parte i diversissimi “Khadak” (2006) e “Altiplano” (2009), ambientati rispettivamente in Mongolia e Perù e attraversati da un percorso autoriale antologico dominato dalla sofferenza come inevitabile spunto per una compiuta rinascita.
Un progressivo disfacimento, ambientale e umano, di un mondo rurale bloccato nel suo inverno ma destinato a sopravvivere in un perenne e grigiastro autunno, un grigio sporcato di fango, sangue e sterco. Una lunga e allegorica messa funebre, capitolo conclusivo d’una trilogia sul rapporto uomo\natura di cui fanno parte i diversissimi “Khadak” (2006) e “Altiplano” (2009), ambientati rispettivamente in Mongolia e Perù e attraversati da un percorso autoriale antologico dominato dalla sofferenza come inevitabile spunto per una compiuta rinascita.
Il cinema indaga il Belgio multirazziale tra difficoltà, drammi e risorse per il futuro
 Molenbeek è un quartiere della zona ovest di Bruxelles, lì ha sede una squadra di calcio femminile che milita nel campionato regionale di Bruxelles-Brabant, al club appartengono circa 120 ragazze dai 6 ai 36 anni provenienti da ogni parte del mondo, in prevalenza Marocco, Turchia, Italia, Tunisia e Libia, tra di loro c’è una ragazza sordomuta scartata da tutti gli altri club e una ragazza musulmana che pur di giocare a calcio ha deciso di togliersi il velo. Sono le “Molenbeek Girls” e aprono le porte a chiunque, vivono nello stesso quartiere recentemente emerso alle cronache come nido del terrorismo islamico in Europa ma che da almeno 20 anni è meta di militanti jihadisti in esilio, un quartiere in cui 2 ragazzi su 5 sono disoccupati, in una città in cui il 65% degli studenti stranieri non termina gli studi e il 20% della popolazione vive sotto la soglia di povertà.
Molenbeek è un quartiere della zona ovest di Bruxelles, lì ha sede una squadra di calcio femminile che milita nel campionato regionale di Bruxelles-Brabant, al club appartengono circa 120 ragazze dai 6 ai 36 anni provenienti da ogni parte del mondo, in prevalenza Marocco, Turchia, Italia, Tunisia e Libia, tra di loro c’è una ragazza sordomuta scartata da tutti gli altri club e una ragazza musulmana che pur di giocare a calcio ha deciso di togliersi il velo. Sono le “Molenbeek Girls” e aprono le porte a chiunque, vivono nello stesso quartiere recentemente emerso alle cronache come nido del terrorismo islamico in Europa ma che da almeno 20 anni è meta di militanti jihadisti in esilio, un quartiere in cui 2 ragazzi su 5 sono disoccupati, in una città in cui il 65% degli studenti stranieri non termina gli studi e il 20% della popolazione vive sotto la soglia di povertà.
Il Belgio ha attualmente una delle nazionali di calcio più forti d’Europa e in rosa ha giocatori originari di Congo, Kenya, Marocco, Indonesia, Kosovo, Martinica, Spagna e si potrebbe continuare. Il Belgio è il centro d’Europa, molto più che geograficamente e Bruxelles è il centro del Belgio molto più che politicamente, è il posto dove Valloni e Fiamminghi convivono, forzatamente o meno, felicemente o meno e insieme con loro c’è il mondo intero, con tutti i suoi problemi portati in braccio.
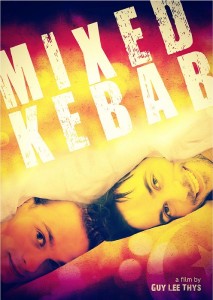 Se c’è qualcosa capace come lo sport di descrivere la multirazzialità e indagarla, andando a fondo in drammi e risorse, questo è il Cinema. Adil El Arbi e Bilall Fallah alla scuola d’arte erano gli unici studenti marocchini e questo li ha uniti al punto da fargli stringere un sodalizio artistico, sono cresciuti con il cinema americano metropolitano e hanno in testa la maniera di Spike Lee e Martin Scorsese di rendere la città una protagonista aggiunta che accompagna e influenza le vicende narrate. Per l’opera che gli ha consacrati hanno però seguito un approccio comune al brasiliano “City Of God”, il loro “Black” (2015) è infatti un West Side Story contemporaneo tra le gang e i quartieri periferici di Bruxelles, una storia d’amore e lotta che muovendosi nei territori del genere, tra crimini, malavita e banlieue, disegna un affresco inedito della capitale belga, un affresco a tinte forti, cupe, che lasciano poca speranza di redenzione, che prendono a pugni lo spettatore travolto da violenza quotidiana e un’ordinarietà fatta di soprusi e discriminazioni.
Se c’è qualcosa capace come lo sport di descrivere la multirazzialità e indagarla, andando a fondo in drammi e risorse, questo è il Cinema. Adil El Arbi e Bilall Fallah alla scuola d’arte erano gli unici studenti marocchini e questo li ha uniti al punto da fargli stringere un sodalizio artistico, sono cresciuti con il cinema americano metropolitano e hanno in testa la maniera di Spike Lee e Martin Scorsese di rendere la città una protagonista aggiunta che accompagna e influenza le vicende narrate. Per l’opera che gli ha consacrati hanno però seguito un approccio comune al brasiliano “City Of God”, il loro “Black” (2015) è infatti un West Side Story contemporaneo tra le gang e i quartieri periferici di Bruxelles, una storia d’amore e lotta che muovendosi nei territori del genere, tra crimini, malavita e banlieue, disegna un affresco inedito della capitale belga, un affresco a tinte forti, cupe, che lasciano poca speranza di redenzione, che prendono a pugni lo spettatore travolto da violenza quotidiana e un’ordinarietà fatta di soprusi e discriminazioni.
Un cinema energico e pulsante che scalcia e sgomita in cerca della propria definizione e maturazione nonché del proprio pubblico. Va infatti sottolineato come i film di Adil El Arbi e Bilall Fallah pur se coprodotti con il fondo per l’audiovisivo della Vallonia, ambientati a Bruxelles e conseguentemente recitati in francese, ottengono grande successo nelle Fiandre ma hanno difficoltà ad affermarsi tra il pubblico francofono della stessa Bruxelles e hanno scarsa distribuzione in Vallonia, quest’ultimo un problema comune a molte produzioni fiamminghe che spesso non hanno affatto una distribuzione in quel territorio.
 Affine a “Black” per canovaccio narrativo ed energia è “Kassablanka” del duo Ivan Boeckmans – Guy Lee Thy, un Romeo e Giulietta variopinto che nel raccontare la difficoltà di un amore impossibile illustra il lato più razzista e intollerante di Anversa, capitale delle Fiandre. Un film vitale che nella tendenza all’accumulo di temi e situazioni offre una visione selvaggia e fagocitante delle problematiche d’integrazione, al punto da divorare anche se stessa in un eccesso di retorica e volgarità strumentali. Meno interessante quel “Mixed Kebab”, diretto dal solo Guy Lee Thy, che si risolve purtroppo in una versione poco ispirata della commedia colorata ed eccentrica alla Almodovar, una maniera un po’ macchiettistica, priva delle soluzioni visive del film precedente e sostanzialmente inconcludente di riflettere sullo scontro e la sovrapposizione di radici, nazionalismi e orientamenti sessuali.
Affine a “Black” per canovaccio narrativo ed energia è “Kassablanka” del duo Ivan Boeckmans – Guy Lee Thy, un Romeo e Giulietta variopinto che nel raccontare la difficoltà di un amore impossibile illustra il lato più razzista e intollerante di Anversa, capitale delle Fiandre. Un film vitale che nella tendenza all’accumulo di temi e situazioni offre una visione selvaggia e fagocitante delle problematiche d’integrazione, al punto da divorare anche se stessa in un eccesso di retorica e volgarità strumentali. Meno interessante quel “Mixed Kebab”, diretto dal solo Guy Lee Thy, che si risolve purtroppo in una versione poco ispirata della commedia colorata ed eccentrica alla Almodovar, una maniera un po’ macchiettistica, priva delle soluzioni visive del film precedente e sostanzialmente inconcludente di riflettere sullo scontro e la sovrapposizione di radici, nazionalismi e orientamenti sessuali.
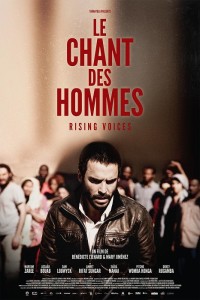 Nel Belgio di questi ultimi e difficili tempi acquistano il proprio spazio anche realtà autoriali in cui le distinzioni di nazionalità, regionalità e lingua sfumano fino a divenire un’entità nuova che, nel riflettere la contemporaneità in sofferente mutazione, crea un cinema eminentemente belga, capace di fondere accenti, stili ed approcci in un’unico spazio di riflessione. É il caso del recentissimo “Le Chant des Hommes” (Rising Voices) (2016) frutto della collaborazione tra l’illuminata Mary Jimenez e Bénédicte Liénard, entrambe provenienti dal documentario e qui avventuratesi in una difficile opera di fiction basata però su eclatanti e ripetuti episodi di cronaca. L’occupazione di una chiesa da parte di migranti in fuga da realtà diversissime ma ugualmente disperate che in una convivenza tesa e forzata danno vita a scontri, incomprensioni e grandi esempi di solidarietà e umanità, alla ricerca continua di una propria voce nel assordante silenzio europeo.
Nel Belgio di questi ultimi e difficili tempi acquistano il proprio spazio anche realtà autoriali in cui le distinzioni di nazionalità, regionalità e lingua sfumano fino a divenire un’entità nuova che, nel riflettere la contemporaneità in sofferente mutazione, crea un cinema eminentemente belga, capace di fondere accenti, stili ed approcci in un’unico spazio di riflessione. É il caso del recentissimo “Le Chant des Hommes” (Rising Voices) (2016) frutto della collaborazione tra l’illuminata Mary Jimenez e Bénédicte Liénard, entrambe provenienti dal documentario e qui avventuratesi in una difficile opera di fiction basata però su eclatanti e ripetuti episodi di cronaca. L’occupazione di una chiesa da parte di migranti in fuga da realtà diversissime ma ugualmente disperate che in una convivenza tesa e forzata danno vita a scontri, incomprensioni e grandi esempi di solidarietà e umanità, alla ricerca continua di una propria voce nel assordante silenzio europeo.
Tecnicamente un film non di stretta produzione fiamminga ma a conti fatti espressione purissima della maniera unica che ha il cinema di abbattere barriere senza annullare differenze e specificità ma piuttosto lavorandoci sopra, oltre che esempio di una sempre più efficace collaborazione in atto tra le diverse entità artistiche e produttive del Belgio, che trova espressione anche in un cinema solo apparentemente più di consumo che esploreremo nei prossimi paragrafi.
Un pubblico dal gusto vario ed esigente decreta il successo commerciale di film dalla forte personalità
 Oltre 1.150.000 biglietti staccati, su un bacino di 6.000.000 di potenziali spettatori, han fatto di Loft (The loft, 2008) il film fiammingo più visto di tutti i tempi ma anche, dato ben più importante, il film belga più visto di tutti i tempi. Qualcosa con cui fare inevitabilmente i conti, specie considerando la sua natura di thriller morboso eppure elegante e rigoroso, caratterizzato da vicende e incastri che costringono lo spettatore a immergersi nelle pieghe di personaggi ognuno con il proprio scheletro nell’armadio, fino a un finale inatteso e un twist di indubbio fascino. Poco importa se la regia geometrica e levigata del primo terzo di film, che tenta mirabilmente di seguire le architetture in cui i fatti si svolgono, si smarrisca pian piano, appiattendosi in una pur efficace accademia. Lo straordinario successo del 4° lungometraggio di Erick Looy, che già aveva avuto un discreto risultato commerciale con l’altro buon thriller De Zaak Alzheimer (The Alzheimer Case, 2003), ha dimostrato sia al pubblico che all’industria la possibilità di realizzare anche nelle Fiandre dell’ottimo cinema di genere e intrattenimento ma al tempo stesso ha palesato l’estrema varietà sia della produzione che soprattutto del gusto fiammingo medio.
Oltre 1.150.000 biglietti staccati, su un bacino di 6.000.000 di potenziali spettatori, han fatto di Loft (The loft, 2008) il film fiammingo più visto di tutti i tempi ma anche, dato ben più importante, il film belga più visto di tutti i tempi. Qualcosa con cui fare inevitabilmente i conti, specie considerando la sua natura di thriller morboso eppure elegante e rigoroso, caratterizzato da vicende e incastri che costringono lo spettatore a immergersi nelle pieghe di personaggi ognuno con il proprio scheletro nell’armadio, fino a un finale inatteso e un twist di indubbio fascino. Poco importa se la regia geometrica e levigata del primo terzo di film, che tenta mirabilmente di seguire le architetture in cui i fatti si svolgono, si smarrisca pian piano, appiattendosi in una pur efficace accademia. Lo straordinario successo del 4° lungometraggio di Erick Looy, che già aveva avuto un discreto risultato commerciale con l’altro buon thriller De Zaak Alzheimer (The Alzheimer Case, 2003), ha dimostrato sia al pubblico che all’industria la possibilità di realizzare anche nelle Fiandre dell’ottimo cinema di genere e intrattenimento ma al tempo stesso ha palesato l’estrema varietà sia della produzione che soprattutto del gusto fiammingo medio.
 Solo un anno prima infatti era stato campione di incassi il coraggioso e assai personale Ben X (Ben X, 2007) di Nick Baltazar, il racconto dell’odissea di disadattamento e dolore di un teenager affetto dalla sindrome di Asperger, vessato dai propri compagni e rinchiuso in un mondo virtuale fatto di giochi di ruolo. Un’opera prima ambiziosa, probabilmente troppo, che se narrativamente non va molto oltre una visione romanticamente e a tratti superficialmente “emo”, visivamente e stilisticamente ha la capacità, seppure solo in dei flash, di provare nervosamente a disegnare quello che probabilmente è impossibile disegnare. Un Cinema sofferto e vitale proprio nel descrivere il vuoto e l’angoscia del non voler più vivere, del non saper vivere.
Solo un anno prima infatti era stato campione di incassi il coraggioso e assai personale Ben X (Ben X, 2007) di Nick Baltazar, il racconto dell’odissea di disadattamento e dolore di un teenager affetto dalla sindrome di Asperger, vessato dai propri compagni e rinchiuso in un mondo virtuale fatto di giochi di ruolo. Un’opera prima ambiziosa, probabilmente troppo, che se narrativamente non va molto oltre una visione romanticamente e a tratti superficialmente “emo”, visivamente e stilisticamente ha la capacità, seppure solo in dei flash, di provare nervosamente a disegnare quello che probabilmente è impossibile disegnare. Un Cinema sofferto e vitale proprio nel descrivere il vuoto e l’angoscia del non voler più vivere, del non saper vivere.
Il talento deviato di Pieter Van Hees
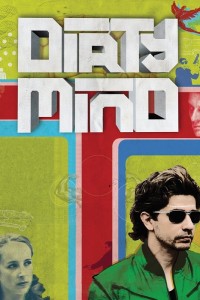 In quegli stessi anni si affaccia nelle sale il talento deviato e senza compromessi di Pieter Van Hees, che con Linkeroever (Left Bank, 2008) dà vita a un contorto e malato thriller dalle profonde venature horror. Tra sette secolari, disagio metropolitano e sessualità come unico mezzo espressivo si dipana un cinema materico e carnale che si insinua nelle viscere del corpo dei suoi protagonisti, risorgendo a un’inevitabile ma nient’affatto rincuorante nuova vita. In una fotografia oscura nasce, esplode e si eclissa nel dolore un amore irrazionale e fagocitante che sembra dare un senso al vuoto finendo poi per annullare il tutto. Primo capitolo, dedicato al corpo, di una trilogia antologica denominata “Anatomia dell’amore e del dolore” a cui seguirà Dirty Mind (2009), dedicato al cervello. Storia di un ragazzo timido e anonimo, un vero perdente che in seguito a un incidente si risveglia trasformato nello spirito, tanto da assumere la personalità di uno stuntman dalla vita eccitante e pericolosa. Tutti vogliono guarire la mente del ragazzo, tutti tranne lui, che sente di poter iniziare a vivere. Van Hees indaga i meandri del cervello umano come una scatola in cui noi stessi creiamo e disfiamo il nostro mondo di illusioni e delusioni, un marchingegno difettoso che nel suo momento di rottura e cortocircuito libera finalmente dai condizionamenti. Immaginazione e realtà si confondono nel non avere interesse su cosa realmente si è, ma impersonando ardentemente cosa si vuole essere.
In quegli stessi anni si affaccia nelle sale il talento deviato e senza compromessi di Pieter Van Hees, che con Linkeroever (Left Bank, 2008) dà vita a un contorto e malato thriller dalle profonde venature horror. Tra sette secolari, disagio metropolitano e sessualità come unico mezzo espressivo si dipana un cinema materico e carnale che si insinua nelle viscere del corpo dei suoi protagonisti, risorgendo a un’inevitabile ma nient’affatto rincuorante nuova vita. In una fotografia oscura nasce, esplode e si eclissa nel dolore un amore irrazionale e fagocitante che sembra dare un senso al vuoto finendo poi per annullare il tutto. Primo capitolo, dedicato al corpo, di una trilogia antologica denominata “Anatomia dell’amore e del dolore” a cui seguirà Dirty Mind (2009), dedicato al cervello. Storia di un ragazzo timido e anonimo, un vero perdente che in seguito a un incidente si risveglia trasformato nello spirito, tanto da assumere la personalità di uno stuntman dalla vita eccitante e pericolosa. Tutti vogliono guarire la mente del ragazzo, tutti tranne lui, che sente di poter iniziare a vivere. Van Hees indaga i meandri del cervello umano come una scatola in cui noi stessi creiamo e disfiamo il nostro mondo di illusioni e delusioni, un marchingegno difettoso che nel suo momento di rottura e cortocircuito libera finalmente dai condizionamenti. Immaginazione e realtà si confondono nel non avere interesse su cosa realmente si è, ma impersonando ardentemente cosa si vuole essere.
 Trilogia conclusasi recentemente con Waste Land (2014), dedicato all’anima. Indossando i panni del più classico dei noir metropolitani, si configura in realtà come un viaggio dantesco nei meandri di tenebre personali e nazionali. Un poliziotto in progressiva crisi matrimoniale si ritrova a indagare un omicidio negli ambienti occulti della comunità congolese di Bruxelles, un’indagine che procede sempre più in profondità seguendo un andamento ellittico che affianca i cicli della gravidanza della moglie e genera un processo di destabilizzazione che risucchia in un abisso di ferocia e violenza tanto il protagonista quanto lo spettatore e coinvolge la storia del Belgio, costretto a specchiarsi in colpe secolari e confrontarsi con la drammaticità del presente. Un’opera sconcertante ma imprescindibile, ignorata all’estero, sebbene presentata al Toronto Film Festival, ma molto apprezzata in patria dove ha ricevuto ben 13 nomination su 14 categorie agli annuali premi del cinema fiammingo.
Trilogia conclusasi recentemente con Waste Land (2014), dedicato all’anima. Indossando i panni del più classico dei noir metropolitani, si configura in realtà come un viaggio dantesco nei meandri di tenebre personali e nazionali. Un poliziotto in progressiva crisi matrimoniale si ritrova a indagare un omicidio negli ambienti occulti della comunità congolese di Bruxelles, un’indagine che procede sempre più in profondità seguendo un andamento ellittico che affianca i cicli della gravidanza della moglie e genera un processo di destabilizzazione che risucchia in un abisso di ferocia e violenza tanto il protagonista quanto lo spettatore e coinvolge la storia del Belgio, costretto a specchiarsi in colpe secolari e confrontarsi con la drammaticità del presente. Un’opera sconcertante ma imprescindibile, ignorata all’estero, sebbene presentata al Toronto Film Festival, ma molto apprezzata in patria dove ha ricevuto ben 13 nomination su 14 categorie agli annuali premi del cinema fiammingo.
Quella del cinema fiammingo contemporaneo è una diversità e unicità rispetto all’intero panorama europeo che trova probabilmente il compimento massimo in personaggi deviati e immersi in vicende livide, avvolte da una cappa di dolore che è specchio di una deriva sociale e personale propria dell’Europa tutta ma che nelle Fiandre è rappresentata senza alcun freno e inibizione ed è assoluta protagonista dei due film più significativi tra quelli trattati: Rundskop (Bullhead, 2011) e De Behandeling (The Treatment, 2014), di cui parleremo diffusamente nell’ultimo paragrafo di questo dossier.
Un cinema che tra male e peggio sceglie sovente l’abisso
 Una ferrovia traccia la linea di demarcazione. Da un lato c’è il mondo e la sua normalità, avvolto da una cappa grigiastra, vestito da un’opaca illusione di serenità, con il passo lento e affannato di chi procede con un peso e ignora d’esser rimasto bloccato in un tempo che fu, in un momento preciso in cui tutto è cambiato, in cui voltando lo sguardo tutto si è fermato. Dall’altro lato c’è l’oblio. Una boscaglia come porta d’ingresso, la selva oscura in cui il veleno nasce e si diffonde a contaminare il mondo. Il cinema che interpreta la storia, legge l’uomo e il suo cancro, raccoglie senza guanti lo schifo prodotto e lo inietta nel cuore dello spettatore senza filtro alcuno. De Behandeling (The Treatment, 2014) diretto da Hans Herbots e scritto da Carl Joos (Alabama Monroe) è opera sconvolgente e disturbante che pur senza mostrare nulla costringe a fare i conti con l’inimmaginabile, con il male assoluto e senza pietà che procede strisciante nei solchi di un noir dall’eleganza ombrosa e annichilente. Seguendo le orme in disfacimento dei migliori thriller americani degli anni ’90, pur senza lasciare spazio a virtuosismi e personalismi estetici, si pone al servizio di una scrittura raffinatissima che nell’intrigo di vicende e situazioni trova un’intelligenza rara e densa per trattare quel dramma nazionale chiamato pedofilia che nessuno come il Belgio ha vissuto in Europa. Un film che nel suo essere inserito nei canoni di un genere classico e nell’avere un impianto tradizionale e codificato sintetizza come nessun altro la livida specificità del cinema fiammingo. Un cinema che tra male e peggio sceglie sovente l’abisso.
Una ferrovia traccia la linea di demarcazione. Da un lato c’è il mondo e la sua normalità, avvolto da una cappa grigiastra, vestito da un’opaca illusione di serenità, con il passo lento e affannato di chi procede con un peso e ignora d’esser rimasto bloccato in un tempo che fu, in un momento preciso in cui tutto è cambiato, in cui voltando lo sguardo tutto si è fermato. Dall’altro lato c’è l’oblio. Una boscaglia come porta d’ingresso, la selva oscura in cui il veleno nasce e si diffonde a contaminare il mondo. Il cinema che interpreta la storia, legge l’uomo e il suo cancro, raccoglie senza guanti lo schifo prodotto e lo inietta nel cuore dello spettatore senza filtro alcuno. De Behandeling (The Treatment, 2014) diretto da Hans Herbots e scritto da Carl Joos (Alabama Monroe) è opera sconvolgente e disturbante che pur senza mostrare nulla costringe a fare i conti con l’inimmaginabile, con il male assoluto e senza pietà che procede strisciante nei solchi di un noir dall’eleganza ombrosa e annichilente. Seguendo le orme in disfacimento dei migliori thriller americani degli anni ’90, pur senza lasciare spazio a virtuosismi e personalismi estetici, si pone al servizio di una scrittura raffinatissima che nell’intrigo di vicende e situazioni trova un’intelligenza rara e densa per trattare quel dramma nazionale chiamato pedofilia che nessuno come il Belgio ha vissuto in Europa. Un film che nel suo essere inserito nei canoni di un genere classico e nell’avere un impianto tradizionale e codificato sintetizza come nessun altro la livida specificità del cinema fiammingo. Un cinema che tra male e peggio sceglie sovente l’abisso.
La serialità come terreno di sperimentazione per il cinema
 La coppia Herbots-Joos, già all’attivo in combutta qualche anno prima nella miniserie The Spiral (2012) (trasmessa in Italia da La Effe), eccentrica coproduzione Anglo\Fiammingo\Scandinava, sorta di reality dai toni del thriller ambientato nel mondo dell’arte e sullo sfondo del mercato nero, ha nella fervida produzione televisiva il terreno di formazione ed esplorazione di stili e temi che spesso nelle Fiandre vengono traslati, anche se con alterne fortune, dal piccolo al grande schermo. E’ il caso del solido action\thriller Windkracht 10 (Storm Force 10, 2006) creato in TV da Joos e portato al cinema con successo da Herbots ben 10 anni dopo o della seguitissima Code 37, serie poliziesca che nell’indagare tra i crimini a sfondo sessuale ha contribuito a svezzare il talento registico di Tim Mielants e Jacob Verbruggen, oramai stabilmente approdati nella serialità anglosassone (Peaky Blinders, London Spy, House Of Cards) e poggiando completamente sul carisma della sua protagonista ha lanciato definitivamente nel firmamento quella Veerle Baetens ora indiscussa star femminile del cinema fiammingo. Sulla serialità televisiva nelle Fiandre sarebbe da indagare e scrivere a fondo, data la varietà di stili, la densità di temi trattati e lo straordinario seguito di pubblico, ma una volta segnalato doverosamente l’efficace thriller cospirazionistico Salamander (trasmesso in Italia da Fox Crime) è qui opportuno concentrarsi su di un’altra grande prova di scrittura di Carl Joos: la distopica e post-apocalittica Cordon.
La coppia Herbots-Joos, già all’attivo in combutta qualche anno prima nella miniserie The Spiral (2012) (trasmessa in Italia da La Effe), eccentrica coproduzione Anglo\Fiammingo\Scandinava, sorta di reality dai toni del thriller ambientato nel mondo dell’arte e sullo sfondo del mercato nero, ha nella fervida produzione televisiva il terreno di formazione ed esplorazione di stili e temi che spesso nelle Fiandre vengono traslati, anche se con alterne fortune, dal piccolo al grande schermo. E’ il caso del solido action\thriller Windkracht 10 (Storm Force 10, 2006) creato in TV da Joos e portato al cinema con successo da Herbots ben 10 anni dopo o della seguitissima Code 37, serie poliziesca che nell’indagare tra i crimini a sfondo sessuale ha contribuito a svezzare il talento registico di Tim Mielants e Jacob Verbruggen, oramai stabilmente approdati nella serialità anglosassone (Peaky Blinders, London Spy, House Of Cards) e poggiando completamente sul carisma della sua protagonista ha lanciato definitivamente nel firmamento quella Veerle Baetens ora indiscussa star femminile del cinema fiammingo. Sulla serialità televisiva nelle Fiandre sarebbe da indagare e scrivere a fondo, data la varietà di stili, la densità di temi trattati e lo straordinario seguito di pubblico, ma una volta segnalato doverosamente l’efficace thriller cospirazionistico Salamander (trasmesso in Italia da Fox Crime) è qui opportuno concentrarsi su di un’altra grande prova di scrittura di Carl Joos: la distopica e post-apocalittica Cordon.
Distopia e post-apocalittico, Cordon: la serialità fiamminga tra le eccellenze europee
 Un virus si diffonde ad Anversa, porta alla follia e alla morte, è irrefrenabile, si può fermare solo tirando su dei muri invalicabili. Mura che dividono in due una città europea. Cordon è una produzione televisiva coraggiosa, per temi trattati soprattutto ma anche per approccio e coralità narrativa. Guarda molto al “genere”, flirtando su più fronti: post-apocalittico, zombi, poliziesco ma è in particolare nelle dinamiche interpersonali e nei cambiamenti che il dramma porta nell’individuo che dà il meglio di sé. Parallelamente disegna scenari socio-politici inquietanti, partendo da degli assunti esasperati e, si spera, inverosimili, delinea pian piano sfumature e rimandi distanti solo un palmo dalla realtà dei nostri giorni, sfumando abilmente e assottigliando il più possibile il confine tra fantascienza, distopia e crudo realismo.
Un virus si diffonde ad Anversa, porta alla follia e alla morte, è irrefrenabile, si può fermare solo tirando su dei muri invalicabili. Mura che dividono in due una città europea. Cordon è una produzione televisiva coraggiosa, per temi trattati soprattutto ma anche per approccio e coralità narrativa. Guarda molto al “genere”, flirtando su più fronti: post-apocalittico, zombi, poliziesco ma è in particolare nelle dinamiche interpersonali e nei cambiamenti che il dramma porta nell’individuo che dà il meglio di sé. Parallelamente disegna scenari socio-politici inquietanti, partendo da degli assunti esasperati e, si spera, inverosimili, delinea pian piano sfumature e rimandi distanti solo un palmo dalla realtà dei nostri giorni, sfumando abilmente e assottigliando il più possibile il confine tra fantascienza, distopia e crudo realismo.
Palle di toro, cuore ferito e sguardo fragile
 Voce fuori campo su fotografia fangosa, un acquitrino di emozioni sepolte che rilegge la tradizione dei naturalisti fiamminghi. Pieter Rubens, Hieronymus Bosh ma anche l’inglese John Constable, esplicitamente citato in fotogrammi che appaiono come una rilettura depressa delle campagne fiamminghe, popolate da anime in pena che vagano con passo pesante e parlano lingue antiche e sepolte, estranee ai loro stessi conterranei ma ancora comprese in remote campagne della Germania settentrionale e Danimarca meridionale. Rundskop (Bullhead, 2011) folgorante esordio cinematografico di Michaël Roskam è recitato per gran parte in un dialetto fiammingo attualmente compreso da meno di 20.000 abitanti delle Fiandre e qui sta parte del carattere di incomunicabilità e alienazione al mondo di un film incentrato sulla corpulenza di un, artisticamente e fisicamente, monumentale Matthias Schoenaerts.
Voce fuori campo su fotografia fangosa, un acquitrino di emozioni sepolte che rilegge la tradizione dei naturalisti fiamminghi. Pieter Rubens, Hieronymus Bosh ma anche l’inglese John Constable, esplicitamente citato in fotogrammi che appaiono come una rilettura depressa delle campagne fiamminghe, popolate da anime in pena che vagano con passo pesante e parlano lingue antiche e sepolte, estranee ai loro stessi conterranei ma ancora comprese in remote campagne della Germania settentrionale e Danimarca meridionale. Rundskop (Bullhead, 2011) folgorante esordio cinematografico di Michaël Roskam è recitato per gran parte in un dialetto fiammingo attualmente compreso da meno di 20.000 abitanti delle Fiandre e qui sta parte del carattere di incomunicabilità e alienazione al mondo di un film incentrato sulla corpulenza di un, artisticamente e fisicamente, monumentale Matthias Schoenaerts.
Un corpo cinematografico che procede nell’esistenza senza apparente significato, nel desiderio di fare del bene ma nella dopata predisposizione a generare il male. Smarrito tra l’incoscienza di cosa non è più e la voglia di tornare a esserlo attraversa il suo paese in un vortice criminale popolato da avventori improbabili, arenandosi nell’impossibilità a relazionarsi. Roskam appare come il talento più puro e imprevedibile emerso dalle Fiandre, confermato anche dal meno personale ma assai efficace The Drop (Chi è senza colpa, 2014) realizzato negli Stati Uniti ed esempio di un cinema semplice fatto di uomini e storie, personaggi che stanno nelle retrovie e vivono rantolanti e a testa bassa.
Qui si conclude questo percorso, per forza di cose parziale e circoscritto, nei meandri di una delle cinematografie più eccentriche e vitali di un continente, l’Europa, in cui oggi si produce con molta probabilità il miglior cinema del mondo. Un viaggio in cui si è preferito tralasciare realtà e autori oramai affermati oltre confine, come lo Jaco Van Dormael di Le tout nouveau testament (Dio esiste e vive a Bruxelles, 2015), o il prolifico cinema per ragazzi da cui sono recentemente scaturite anche interessanti ibridazioni come il gustoso slasher\horror Welp (Cub – Piccole prede, 2014), in favore di opere e autori più identitari e generalmente al di fuori dei radar internazionali.
fine…
Qui sotto lo spot italiano di Cub – Piccole prede:
© Riproduzione riservata